Generazioni
solidali
Generazioni solidali, a cura di Marco Accorinti ed Enrico Pugliese, (Liberetà, 2015) è un libro che parte dalla condizione degli anziani per raccontare le criticità presenti e future con cui confrontarsi
La vecchiaia non è un posto per femminucce.
Bette Davis, Attrice
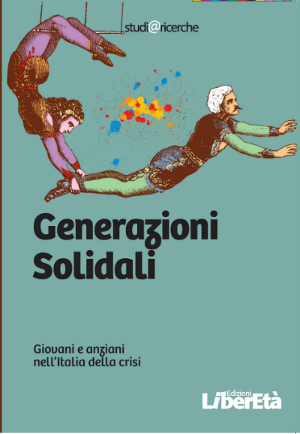 Chi si avvicinasse al volume curato da Marco Accorinti ed Enrico Pugliese, Generazioni solidali. Giovani e anziani nell’Italia della crisi (Liberetà, 2015), pensando di trovarsi solo di fronte a un libro dedicato agli anziani resterebbe sorpreso. Il libro infatti parte sì dai risultati di una ricerca sulla condizione degli anziani, ma fornisce in realtà un quadro più ampio rispetto a diverse dimensioni, da quella demografica a quella lavorativa, da quella sociale a quella culturale. Un bel viaggio nel paese che oggi siamo e un’ottima occasione per ragionare di genere oltre che di generazioni.
Chi si avvicinasse al volume curato da Marco Accorinti ed Enrico Pugliese, Generazioni solidali. Giovani e anziani nell’Italia della crisi (Liberetà, 2015), pensando di trovarsi solo di fronte a un libro dedicato agli anziani resterebbe sorpreso. Il libro infatti parte sì dai risultati di una ricerca sulla condizione degli anziani, ma fornisce in realtà un quadro più ampio rispetto a diverse dimensioni, da quella demografica a quella lavorativa, da quella sociale a quella culturale. Un bel viaggio nel paese che oggi siamo e un’ottima occasione per ragionare di genere oltre che di generazioni.
Il prisma attraverso cui sono indagati i diversi aspetti della società è l’invecchiamento della popolazione e le relazioni fra generazioni.
Il Novecento è stato il secolo della solidarietà fra generazioni ma anche della grande trasformazione demografica portata dall’invecchiamento della popolazione. Nel nuovo millennio i rapporti di solidarietà fra generazioni vengono minati dall’erosione dei sistemi di protezione sociale che aumentano le povertà e modificano anche le relazioni generazionali. Ne derivano assetti inediti della società che provengono da un lato da una nuova considerazione sociale della vecchiaia, dall’altro dalle nuove relazioni che si determinano fra generazioni. Pur non essendo esplicito intento degli autori, è possibile ricavare dal volume una lettura di genere delle trasformazioni in atto.
In primo luogo: hanno pari opportunità le donne e gli uomini che invecchiano in questo paese? La risposta che se ne ricava è: non ancora. E questo perché le condizioni in vecchiaia dipendono in larga parte da quelle che sono state le condizioni economiche, lavorative, territoriali e sociali della vita precedente. Sesso, età, titolo di studio, area territoriale di residenza e legami sociali cambiano in misura sostanziale quello che, a differenza di un tempo, è oggi il variegato e accresciuto universo della popolazione anziana nel paese. Le diversità fra percorsi maschili e femminili, che caratterizzano tutta la vita, si riverberano con forza in vecchiaia. Certo la condizione anziana è complessivamente molto migliorata nel corso del tempo sia perché è cambiata la portata del fenomeno, la cui incidenza non è mai stata così elevata nella storia, sia perché ne è cambiata socialmente la considerazione. Un tempo la vecchiaia era una condizione da tenere nascosta spesso di pessima qualità; Simone de Beauvoir negli anni Sessanta sentiva di definirla “una sorta di segreto vergognoso, di cui non sta bene parlare”. Oggi una una società in cui sempre più anziani hanno una vita attiva e in salute è, se non generalizzato, almeno ipotizzabile.
Ma chi è anziano? È anziano chi la società definisce tale. E la definizione dipende dai cambiamenti che intervengono nelle condizioni e nell’entità della popolazione che si presenta alla soglia dell’anzianità, che cambia nel tempo e che riflette il grado di sviluppo socio-economico di un paese. Tanto per intenderci, è tutta recente la distinzione fra terza e quarta età che dipende dall’allungamento della vita media e dalla migliore condizione in cui questa vita si snoda. Oggi, per convenzione, è anziana la popolazione che ha superato il sessantacinquesimo anno di vita e vecchia quella dagli 80 anni in su. L’Italia è oggi il secondo paese dopo il Giappone per percentuale di ultrasessantenni, al primo posto per quella di ultraottantenni, al secondo posto per velocità di invecchiamento. Vuol dire che è aumentato il numero di anziani, ma anche l’incidenza dell'invecchiamento sulla popolazione.
L’invecchiamento è un processo che subisce l’influenza poi di altre variabili: dallo stato di salute alla quantità e qualità delle relazioni sociali che si instaurano. E anche su queste, determinante è l’appartenenza di genere. In tal modo l’invecchiamento diventa un concetto dinamico, connesso allo stato di agio o di disagio in cui si vive l’accadere di eventi come il pensionamento, la vedovanza, il peggioramento delle condizioni di salute, l’infermità.
In Italia oggi ci sono più anziane che anziani e più vedove che vedovi, ma si assiste ad un progressivo riequilibrio grazie a una maggiore sopravvivenza dei maschi rispetto al passato: questo potrebbe proseguire anche in futuro con garanzia di una più lunga vita di coppia e migliori possibilità di indipendenza economica e di auto-aiuto delle coppie. L’aumento del carico demografico degli anziani si traduce però in un aumento del carico di assistenza ancora in larga misura per le donne. Il rapporto di cura femminile degli anziani indica che per ogni donna fra i 45 e i 64 anni ci sono circa 0,4 ultraottantenni; un rapporto che negli ultimi vent’anni si è mantenuto abbastanza basso e soddisfacente sia per la scarsità dei "vecchi" che per l’ampiezza delle generazioni da loro messe al mondo. Nel tempo questo rapporto è destinato a crescere, questo vuol dire che se non si ripensano modalità e organizzazione dell’assistenza, le donne in età matura in Italia si ritroveranno un carico decisamente insostenibile.
Le questioni della salute in vecchiaia sono rilevanti. Molto dipende ancora una volta dal sesso e dall’età raggiunta. Una popolazione che invecchia, e che raggiunge in massa età avanzate, presenterà una gamma di patologie ampia e diversificata anche in base al sesso. Pertanto un sistema sanitario deve essere in grado di rispondere e prevenire in maniera ampia e duttile tali diversità. Se le nuove generazioni di anziani sono entrate nell’età anziana con migliori condizioni di vita e cure migliori delle generazioni precedenti, si rilevano ancora troppe differenze terrritoriali e di genere. Se consideriamo la maggior speranza di vita delle donne (85,0 anni contro gli 80,3 anni degli uomini nel 2014), se ne deduce che le donne vivono sì più a lungo, ma in peggiori condizioni di salute.
Una delle variabili più rilevanti per definire l’agio di una vita anziana è la collocazione avuta nel mercato del lavoro. La maggiore esclusione femminile dal mercato del lavoro, la più difficile partecipazione e i più bassi tassi di occupazione accanto a carriere interrotte, part-time e differenziali salariali definiscono peggio la condizione da anziane, la capacità di curarsi, la possibilità di accedere ad un invecchiamento attivo e di avere una vita sociale. Le carriere nel mercato e nel lavoro rendono le donne più vulnerabili e pertanto a maggiore rischio di povertà. Certo si potrebbe dire che la registrata crescita del tasso di occupazione delle generazioni anziane dia oggi garanzia di un maggiore reddito, ma da un lato esso è stato prodotto da misure previdenziali punitive che non hanno consentito nuovi accessi e dall’altro il tasso di attività femminile anziana resta ancora al 2012 di oltre 20 punti percentuali più basso di quello maschile.
Oggi in Italia si registra una maggiore tenuta dei reddito degli anziani rispetto ad un generale impoverimento della popolazione italiana e questo fa sì che interi nuclei familiari con membri non occupati siano sostenuti dalle pensioni degli anziani. Si è così configurata una solidarietà intergenerazionale che per la prima volta va dai padri ai figli, quando solo negli anni Sessanta essa andava dai figli - che con il loro reddito ne assicuravano la vecchiaia - ai padri. Pertanto la povertà oggi non è tanto degli anziani, ma delle famiglie alle quali gli anziani sono collegati. Con una prevalenza di queste realtà nel Mezzogiorno.
Il genere influenza anche fortemente il comportamento e la gestione della vita quotidiana. Per le donne anziane è ancora il carico domestico che riduce la loro partecipazione alle attività sociali e di volontariato. Anche qui lo stile di vita dipende da condizioni economiche e livello di istruzione. Ma in generale le anziane sono più sole degli uomini. Risultato di uno stile di vita ancora meno proiettato di quello degli uomini alla socialità.
La politica dovrebbe ripensare a un nuovo contributo che le generazioni anziane potrebbero dare alla società complessiva e includere una prospettiva di genere che prenda in considerazione da un lato i diversi bisogni, dall’altra le diverse istanze che uomini e donne possono esprimere durante l’invecchiamento. Sarebbe un'altra ottima strategia di inclusione e superamento delle disparità di genere.