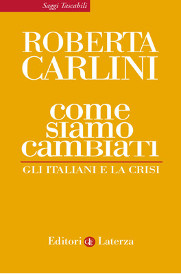Roberta Carlini "riassegna alle statistiche la loro funzione primaria, quella appassionante del ‘render conto’, di rappresentare realtà complesse e di porre domande concrete a chi di quei numeri è parte". Come siamo cambiati. Gli italiani e la crisi (Laterza 2015), nella recensione di Paola Masi
Diversamente da molti opuscoli in circolazione, l'ultimo libro di Roberta Carlini affronta i mutamenti avvenuti nella società italiana nell'ultimo decennio così come svelati, ma non necessariamente prodotti, dalla recente crisi finanziaria ed economica. Come precisa l'autrice nell'introduzione, lo scopo non è raccontare la crisi, né le sue vittime, né le sue motivazioni economiche. Al contrario, l'idea è quella di usare i sommovimenti economici accaduti in un arco di tempo che Carlini chiama la "Grande Recessione", dal 2007 a oggi, per mostrare i cambiamenti profondi, quelli "non di passaggio", che sono maturati durante quel periodo e che erano già presenti prima di essa. La crisi, finanziaria e reale, ha accelerato o aggravato tendenze in atto, ciò che eravamo senza saperlo.
Siamo cambiati, dunque, irreversibilmente. Il libro scandisce il passaggio analizzando sei pilastri della vita collettiva e personale delle italiane e degli italiani: i profili demografici, la famiglia, il lavoro, i consumi, la formazione, le diseguaglianze sociali. Il metodo, anche in questo caso, non cede alle mode 'narrative' del momento. Più che dalle testimonianze sul campo, infatti, l'analisi parte dai numeri, quelli delle statistiche ufficiali: la società italiana viene scandagliata con uno sguardo al medio periodo, descrivendo i fenomeni e le loro connessioni, e soprattutto mostrando le questioni e i dubbi che nascono dai numeri. Recuperando un metodo 'antico', Carlini riassegna alle statistiche la loro funzione primaria, quella appassionante del ‘render conto’, di rappresentare realtà complesse e di porre domande concrete a chi di quei numeri è parte.
I tratti del "popolo che ora siamo" sfuggono alle semplificazioni e alle letture superficiali del cambiamento. Così Carlini affronta il calo della natalità e la baby recession - il rapporto tra PIL e culle vuote - registrato in Italia, senza schiacciarlo sulla crisi, bensì ricostruendolo nei suoi andamenti non lineari e geograficamente disomogenei. Anche in Italia, come nel resto di Europa, esiste un legame diretto tra livelli di occupazione femminile e decisione di fare figli; ma Carlini ci dice qualcosa in più: il fattore principale nel determinare le scelte di riprodursi - tra le rinunce e i rinvii delle varie fasce di donne fertili - non è tanto il livello del reddito disponibile quanto le condizioni di lavoro (incertezza, tutele, ecc.) delle donne e dei loro partner. Il fatto poi che le famiglie siano diventate un nucleo di resistenza alla crisi, nonostante le nuove vulnerabilità finanziarie e la decrescita degli indicatori di nuzialità - una costante da oltre un cinquantennio -, è legato a ben vedere al consolidarsi di un fenomeno tutto italiano, il ritorno o la permanenza nella famiglia di origine delle nuove generazioni, dove il vero crollo è quello del tasso di autonomia dei nati negli anni Novanta del secolo scorso.
Riprendendo le analisi delle economiste di Ingenere, l'autrice ricorda che la crisi ha colpito i lavori degli uomini (finanza, edilizia) ma che non ha intaccato il tasso di attività femminile - che include anche le donne che cercano lavoro -, costantemente cresciuto. Le donne, allineate agli uomini nella fascia più bassa di occupazione, disoccupazione, salari, sono state decisive nelle fasce medio alte per conservare il tenore di vita delle convivenze e hanno fatto la differenza nelle famiglie in bilico sulla soglia della povertà. Pur senza semplificare, proprio la crisi conferma che il primo fattore di cambiamento della società italiana, impensabile pochi decenni fa, è legato al ruolo delle donne, ai loro lavori, ai loro stili di vita.
Dopo aver analizzato con inquietudine gli effetti della grande recessione sui consumi e sulla "oculata spending review fatta dalle famiglie italiane", il libro tocca le aree più problematiche del cambiamento: la formazione del capitale umano e le diseguaglianze sociali. Qui le conseguenze del passaggio avvenuto nella società italiana lasciano pochi margini di ottimismo.
L'autrice descrive un paese che invece d'investire nell'unica risorsa primaria di cui dispone, il capitale umano, decide di tagliare i fondi sulla conoscenza e sulla formazione; che assiste, assecondandolo, a un esodo imponente dalle università; che ha una percentuale di laureati in diminuzione pur avendo un numero di laureati pari ad appena il 14 per cento del totale della popolazione, inferiore di più di dieci punti alla media europea (nella composizione a 27 paesi); che taglia le borse di studio, gli alloggi universitari, le agevolazioni fiscali per i meno favoriti, accettando che 30 diciannovenni su 100 che s'iscrivono all'università provengano da contesti familiari favoriti e abbiano almeno un genitore laureato; che, nella prospettiva più rosea, premia la "meritocrazia ereditaria" come la definisce l'Economist, ripreso attentamente dall'autrice. Non va meglio per la diseguaglianza sociale, nonostante la nuova attenzione alla distribuzione del reddito e della ricchezza nata dalle proteste di Zuccotti Park, dai 'no logo' della Klein e, da ultimo, dal successo delle ricerche di Thomas Piketty. Dal 2007 gli indicatori della popolazione a rischio povertà aumentano in Europa solo per l'Italia e la Grecia; e non va meglio per le aspettative di futuro, dove è ancor più evidente che i danni 'non occasionali' prodotti dalla 'grande recessione' segnano le prospettive dei trentenni di oggi, sia rispetto alle generazioni dei propri genitori, sia dei propri simili di appena un decennio precedente. Tristemente le ultime indagini sulla ricchezza delle famiglie della Banca d'Italia per il 2014 confermano una ricchezza media netta delle famiglie per età del capofamiglia inferiore ai 35 anni in netta diminuzione negli ultimi vent'anni.
Il disegno che emerge dai cambiamenti degli italiani offre molte ragioni per essere attenti e preoccupati, seppure ‘non pessimisti’, come vorrebbe la stessa autrice. Il libro indica però una necessità: tracciare i cambiamenti può essere sgradevole e faticoso ma è condizione necessaria per vedere la nostra contemporaneità e per sperare di condividerne il senso. La speranza secondo il mito, era l'unico 'spirito' che non uscì dal vaso di Pandora e che lei, saggiamente, amministrò per cominciare a riordinare un mondo - certamente ancora maschilista - sconvolto dalle conseguenze della sua curiosità.
Roberta Carlini, Come siamo cambiati. Gli italiani e la crisi, Laterza, Bari, 2015, euro 13,00