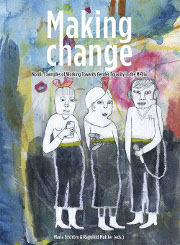Qual è il ruolo dei media nella veicolazione della cultura di genere? Sguardi dal Nord Europa nel libro Making Change. Nordic examples of working towards gender equality in the media, curato da Maria Edström e Ragnhild Mølster
Il libro Making Change. Nordic examples of working towards gender equality in the media, curato da Maria Edström e Ragnhild Mølster, parte da domande centrali per chi rifletta sui media e sull’industria culturale in un'ottica di genere: qual è il loro ruolo? Leve di cambiamento o apparati destinati a riprodurre il vigente ordine delle relazioni di genere? Se, chiaramente, questi sono da sempre i principali termini del dibattito entro i gender media studies, una domanda più precisa e identificativa del volume riguarda l'esistenza di una specifica 'nordic way' alla realizzazione, o almeno persecuzione, dell’uguaglianza di genere nei media.
Tale interrogativo viene declinato in relazione allo stato di quattro comparti mediali (cinema, giornalismo, computer games e pubblicità) in cinque paesi (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) ed esplorato attraverso un approccio che costituisce anche uno dei principali punti di interesse del libro: la triangolazione di sguardi, saperi, vissuti diversi, portati da autori/autrici che parlano in prima persona o a nome di un’organizzazione, e provengono dall’accademia come dalla società civile, dall’industria mediale come dall’attivismo. Per ciascuno dei settori in analisi, si illustrano criticità e buone pratiche, si offrono risultati di ricerche e testimonianze dirette.
Completano il libro la sezione ‘Iniziative’, dedicata a progetti di successo, aventi per oggetto uno o più media, e la sezione ‘Statistiche’: 40 pagine in cui, comparto per comparto e paese per paese – così da consentire confronti – si riportano tabelle e grafici relativi all’impiego di donne e uomini nelle organizzazioni mediali, ai ruoli professionali ricoperti, alla distribuzione dei finanziamenti statali e non tra le opere mediali rispettivamente prodotte dalle une e dagli altri.
Questa vera e propria miniera di dati ben riflette la scelta di fondo del volume, che consiste nel subordinare la dimensione qualitativa della uguaglianza di genere a quella quantitativa, come peraltro esplicitato fin dalla prefazione:
La parità di genere ha molte definizioni qualitative. Una delle quali è che uomini e donne hanno le stesse possibilità di dar forma alla società e alle proprie vite. Ma senza le statistiche come sappiamo qual è il problema e in che direzione stiamo andando? Misuriamo quello che per noi è importante. (p. 10)
Compiere un bilancio di genere delle organizzazioni mediali è dunque il fine principale del volume, e, se l’appendice 'Statistiche' tratteggia una panoramica generale, i singoli contributi offrono uno zoom su realtà specifiche e decisamente eloquenti.
Il volume offre un’ampia base di dati, risorsa imprescindibile per qualunque ragionamento, anche e soprattutto in ottica comparativa. Per dirla con una delle autrici, Lotta Strömland, che per anni ha lavorato presso un delle redazioni regionali del network televisivo di servizio pubblico (SVT), il monitoraggio quantitativo è compito da svolgere ogni settimana, perché
La parità di genere è un noioso lavoro quotidiano. È come lavare i piatti - devi farlo dopo ogni pasto se vuoi tenere la cucina pulita. Appena pensi che hai finito e hai capito come fare ci sono già nuovi piatti da lavare (p. 62).
Tuttavia, la preminenza accordata alla dimensione quantitativa dell’uguaglianza di genere in alcuni contributi finisce per essere ‘assolutizzata’ e originare un assunto mistificatorio: più donne nella produzione, più gender equality tanto nella struttura delle organizzazioni mediali quanto nei loro contenuti. Senza addentrarci in un dibattito che peraltro si ripropone immutato in tanti altri settori della vita associata, dalla rappresentanza politica all’economia, qui basti osservare come a indirizzare verso questa equazione concorre anche un altrettanto problematico legame deterministico che alcuni contributi istituiscono tra il piano della produzione e quello della rappresentazione.
Ad esempio, così si legge in un saggio che guarda positivamente a misure per incrementare le quote femminili nell’industria cinematografica:
Le autrici e le registe tendono a raccontare storie che parlano di donne molto di più di quanto non facciano gli uomini. In questo senso c'è una relazione chiara ed evidente tra la produzione e la rappresentazione. (p. 18).
Certo, tendenzialmente, un’accresciuta femminilizzazione del comparto produttivo incrementa anche le chances di una femminilizzazione degli universi tematici, delle storie, dei loro/delle loro protagoniste; ma ciò non sempre è vero, neppure in quei paesi del nord Europa cui spesso guardiamo come modelli, come dimostrano peraltro anche altri contributi del volume:
Ci si aspetterebbe che l'alto numero di donne presenti nell'industria dell'informazione si riflettesse nelle notizie prodotte. Anche se questo in alcuni casi è vero, i contenuti delle notizie continuano a essere fortemente maschili quando parliamo di rappresentazione e parità di genere. (p. 48).
Ma soprattutto, per dirla in modo triviale, la quantità non fa necessariamente la qualità; oltre a ‘quanto’ sono presenti le donne nei prodotti mediali è necessario indagare anche ‘come’ lo sono, ovvero le forme della loro presenza: i modelli di ruolo maschili e femminili, il modo in cui si rappresenta il rapporto fra i sessi, l’immaginario di genere complessivamente tracciato da radio, tv, web, cinema, ecc. Pur nei rigidi limiti di spazio, che impongono di sintetizzare i risultati, questo è ciò che si fa in altri contributi, dove il nesso strutture produttive/forme della rappresentazione è indagato più a fondo e con approcci metodologici compositi, che integrano l’analisi quantitativa - impiegata per le prime - con strumenti qualitativi, più adeguati ad affrontare lo studio delle seconde. Ad esempio, nel già citato capitolo Counting heads and keeping an eye on the content, dedicato al cinema, si compie un’analisi dei ruoli narrativi in cui compaiono donne e uomini nei film distribuiti nei paesi scandinavi nel 2012 e si rileva come i personaggi femminili risultino complessivamente più passivi e dipendenti (dagli uomini). Il dato viene spiegato alla luce della massiccia occupazione dei ruoli chiave dell’industria da parte degli uomini, da un lato, e di uno ‘spettatore modello’ che si ipotizza maschile.
Questo contributo ben rappresenta lo spirito del volume perché impiega l’analisi del contenuto, la prima e più longeva metodologia utilizzata negli studi femministi sui media, inaugurata negli anni ’70 in ambito statunitense. Benché utile per molti aspetti, essa risente oggi come allora di un ‘vizio’ di fondo: la concezione dei media come specchi che debbano riflettere e quindi rischino di distorcere la presunta ‘realtà’ sociale - in questo caso quella di genere e dei rapporti di genere.
Una simile visione, d’altronde, emerge fin dalla prefazione, dove si enuclea lo scopo del libro in questi termini: "contrastare la disuguaglianza di genere ma anche la rappresentazione distorta dei media", e ricorre tanto nei saggi accademici - che utilizzano, appunto, l’analisi del contenuto - quanto in quelli scritti da professionisti, dove frequentemente si motiva l’utilità di analisi quantitative e azioni correttive del gender imbalance nei media, proprio attraverso la metafora dello specchio:
Per dire che la filmografia svedese è rappresentativa, le storie devono rispecchiare la società contemporanea. Solo permettendo alle donne di avere le stesse chance degli uomini di raccontare le loro storie nei film prodotti potremmo dire di avere una rappresentazione giusta dei nostri tempi. (p. 25).
Altrettanto accade a proposito della pubblicità:
Un industria con un ruolo così importante nel discorso pubblico dovrebbe rappresentare e rispecchiare la società quando si parla di etnicità, classe, estrazione socioeconomica così come del linguaggio e l'esperienza. (p. 110)
Il limite di questo approccio è che trascura un aspetto importante del funzionamento dei media: essi non si limitano a riflettere, in modo più o meno fedele, una presenta realtà sociale, ma attivamente partecipano alla costruzione di questa; più che sovrarappresentare o sottorappresentare i ruoli, le identità, le posizioni soggettive effettivamente ricoperte dalle donne nella società, i media contribuiscono a riprodurre, modificare, in ogni caso costruire quelle identità, offrendo materiali simbolici (storie, valori, modelli di comportamento, ecc.) che maschi e femmine impiegano nel processo per divenire donne e uomini. Qui risiede la più importante lezione dei paradigmi sociologici che afferiscono al costruttivismo, che guardano ai media, appunto, come ‘definers of social reality’ (Tony Bennett, 1969) e, che, impiegati nello studio dei media in ottica di genere, si interrogano sulla costruzione discorsiva del femminile e del maschile.
Nel volume, un solo contributo – Gender and computer games in the construction of identity, di Silje H. Hommedal - mutua questo approccio, ma vale la pena di citarlo perché efficace e incentrato sul relativamente poco esplorato comparto dei computer games: l’autrice si chiede quali siano le aspettative, in termini di genere, diffuse nella nostra società attorno ai computer games (‘roba da maschi’ o anche ‘da femmine’?) e se i giovani incorporino o piuttosto rigettino tali aspettative nei processi di costruzione della loro identità di genere. L’approccio usato, dichiaratamente, si basa sulla teoria femminista post-struttualista, che concepisce il genere come costrutto culturale e – a riprova di quanto dicevamo – sulle teorie sociali costruttiviste, "che considerano la società e la tecnologia come sfere che mutualmente si co-costruiscono" (p. 93).
Esempi cui guardare
Decisamente utile la panoramica fornita, per ogni singolo comparto dell’industria mediale sotto analisi, degli strumenti legislativi,delle buone pratiche e iniziative volte a favorire l’uguaglianza di genere, tanto nella struttura produttiva quanto nelle rappresentazioni. Certo, di nuovo la dimensione di riferimento è quella quantitativa, e lo scopo delle iniziative illustrate è riequilibrare le asimmetrie, in primis numeriche. Così, ad esempio, un’esperienza interessante nell’ambito del cinema appartiene allo Swedish Film Institute, che divide al 50% i finanziamenti per la produzione di film diretti da uomini e donne, assicurando un’equilibrata presenza degli uni e delle altre anche nei ruoli di sceneggiatore e produttore (p.25).
La ricetta di un costante monitoraggio quantitativo è applicata in modo programmatico da alcune realtà mediali, soprattutto nell’ambito del giornalismo: un quotidiano svedese è riuscito in questo modo (rilevazioni su articoli e foto condotte per un’intera settimana ogni quattro) a rovesciare la tendenza che, anche in Svezia, vede le donne essere soggetto delle news solo nel 23% del totale, portando tale percentuale al 49%. Altrettanto fa il network di pubblico servizio, SVT, che compie un gender balance di ogni programma prodotto in proprio e mira a contenere il gap tra uomini e donne entro i 10 punti percentuali su base annuale.
Proviene dalla Danimarca un’importante inizitiva volta a controbilanciare la maschilizzazione della workforce dell’industria del gaming digitale così come la prospettiva, dominante in molti giochi, del ‘Western, white male’: sitratta del Game Girl Workshop, un seminario intensivo in cui le ragazze vengono incoraggiate a cimentarsi con la tecnologia e sviluppare computer games basati sulla loro fantasia e esperienze.
Infine, per la pubblicità, chiaramente uno dei comparti più sensibili data la sua pervasività e capacità di role-modeling, molte e davvero d'ispirazione sono le esperienze collezionate nei paesi scandinavi, come testimoniato dal capitolo sugli organi di autoregolamentazione ma anche dalle iniziative educative e culturali: una su tutte, indicativa della maturità di questi paesi sul fronte delle gender issues - nonostante le ‘nude’ cifre, come abbiamo visto, spesso dicano il contrario – e della consapevolezza del ruolo giocato dai media: in Norvegia è nato il network Ungdom Mot Retusjert Reklame [Youth against retouched advertisements], che dal 2010 riunisce giovani e giovanissimi e si batte contro il cruciale problema delle immagini pubblicitarie ‘ritoccate’ (con photoshop o altri software) e dei loro modelli estetici femminili e maschili,tanto artificiali quanto inarrivabili.