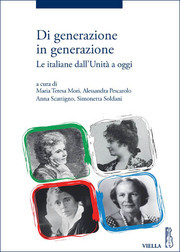Di generazione in generazione mette in luce sia l'importanza delle genealogie per le identità individuali che la conflittualità del rapporto tra generazioni e lo fa attraverso la parola delle storiche italiane e il racconto delle donne nella storia.
Questo corposo volume – 20 saggi più l’introduzione – è frutto di un convegno tenutosi a Firenze nel 2011, organizzato dalla Società Italiana delle Storiche nell’ambito degli eventi celebrativi intorno ai 150 anni dell’unità d’Italia; in esso, storiche di lunga e sapiente esperienza (tra le quali, Simonetta Soldani, Nadia Maria Filippini, Michela De Giorgio, Anna Scattigno, Valeria Babini, Alessandra Pescarolo, Mariuccia Salvati, la letterata Marina Zancan, la sociologa Carmen Leccardi) accompagnate da un affermato specialista dell’800 (Marco Meriggi), si alternano a studiose nate dopo gli anni ’60 (Stefania Bartoloni, Liliana Ellena, Barbara Imbergamo, e altre), insieme alle quali figura anche un giovane sociologo (Luca Salmieri).
Per l’occasione, non poteva esserci tema maggiormente pertinente di quello che compare nel titolo. Di generazione in generazione suggerisce non solo la rilevanza per le identità individuali e collettive dei passaggi o delle discendenze, ma anche – forse soprattutto, considerate le consapevolezze attuali - una serie di relazioni complesse che spesso evidenziano l’esistenza di contrasti di svariata natura; ad indicare che non si tratta di semplice trasmissione nel senso di dare e ricevere come in un dinamico e reciproco scambio. Quelli in gioco sono piuttosto vincoli, similitudini, dipendenze, conflitti, dissensi, fratture. Mai come negli ultimi decenni sono stati soprattutto contrasti e disuguaglianze a suggerire una caratterizzazione dei rapporti tra le generazioni dai significati più consoni, dal punto di vista economico e sociale, alla fase critica che attraversiamo. Così sembrano indicare le diverse suddivisioni in cui il libro è organizzato: le prime sei sottolineano gli elementi che accomunano le donne intorno a determinati ideali e comportamenti politici e pubblici – la patria nel periodo che segue l’unificazione; la scrittura e la maternità dalla fine dell’800 al primo dopoguerra; il fascismo e la prima repubblica; il femminismo dagli anni ’70 in avanti. I cinque saggi delle ultime due sezioni sottolineano le contraddizioni e incertezze del passato prossimo e del presente, con una chiarissima indicazione problematica nell’ultima parte, intitolata “Ostinazione dei progetti, opacità del futuro”. Su alcuni di essi mi soffermo brevemente più avanti.
All’interno di un quadro storiografico e sociologico consolidato che in Italia negli ultimi anni ha mostrato di avere finalmente acquisito maggiore sensibilità nei confronti di una presenza femminile nella formazione della identità nazionale, e di avere sollevato questioni fondamentali relative all’esercizio della cittadinanza attiva, il volume nel suo insieme soddisfa pienamente l’obiettivo di rendere visibile e documentato il ruolo delle donne nello sforzo di costruzione dello stato unitario, soprattutto attraverso l’impegno nel campo dell’istruzione e della partecipazione alla vita politica, seppure spesso in posizione subalterna e in ombra. Per ciascun saggio il riflettore si accende intorno a una figura prescelta, e l’ampio uso della biografia si conferma come una metodologia feconda, che serve a comporre un quadro storico animato da singole protagoniste seguite attraverso percorsi di vita spesso tormentati e faticosi (per l’800 Erminia Fuà Fusinato, Giannina Milli, Matilde Serao; e poi nel ‘900: Sarfatti, Anselmi, Iotti, Carla Lonzi). Largamente condivisibili, inoltre, le considerazioni introduttive, che invitano a riflettere sulle continuità e rotture delle generazioni che si sono succedute dall’Unità in poi, per poi accennare alla complessità di scelte possibili per le giovani nell’attuale fase di incertezza economica, “che ha cristallizzato la fragilità degli uomini in termini educativi e chiuso le opportunità professionali delle donne istruite, ormai più numerose degli uomini.”
Proprio le difficoltà di tentare delle interpretazioni sul passato prossimo e sul presente, fanno apprezzare i saggi delle ultime sezioni, che offrono percorsi di analisi inconsueti e assai stimolanti; in particolare su temi rilevanti come il femminismo dopo gli anni Settanta, sviluppato da Liliana Ellena, il lavoro autonomo descritto da Barbara Imbergamo, e il divario di genere tra istruzione e lavoro analizzato da Luca Salmieri. Molto diversi come approccio, così come diversi per provenienza e formazione sono le autrici e autore, è soprattutto leggendoli che il libro comunica con efficacia le difficoltà esistenti nel tracciare anche solo un disegno appena abbozzato di cosa passa, rimane nascosto, rifiutato, distante, tra le generazioni lungo un secolo e mezzo. Inoltre, tutti e tre affrontano la questione del rapporto con il tempo in maniere assai differenti.
Per Ellena non è affatto scontato sistemare il movimento delle donne dei Settanta all’interno di chiavi di lettura consolidate. A partire dal binomio storicamente problematico di ‘libertà/liberazione’, secondo questa analisi si delinea un insieme di configurazioni spazio-temporali eterogenee e inedite. Nello stabilire il ruolo centrale svolto da corpo e sessualità, il femminismo innesca infatti un processo di scardinamento del tradizionale binomio diritti civili/identità nazionale, che consente di poter configurare, per gli anni ’60 e ’70, un vero e proprio cambio di paradigma e una situazione di “snazionalizzazione delle italiane”. Al contrario, nel variegato ritratto autobiografico offerto da Imbergamo - studiosa del movimento delle mondine nel primo Novecento e attualmente imprenditrice autonoma, con un percorso a ostacoli tra desiderio di affermazione professionale come storica, desiderio di maternità, autonomia economica, permanente insicurezza esistenziale - il presente viene interpretato traendo un enorme profitto dalle esperienze di quelle donne coraggiose che hanno lottato per i diritti delle lavoratrici madri, e per denunciare sfruttamento e condizioni di precariato cento anni fa; qualcosa che rende le donne di un secolo orsono molto vicine alle donne nel momento attuale, eppure lontanissime e irraggiungibili. Attraverso una puntuale ricognizione sui destini delle giovani negli ultimi decenni, Salmieri offre una intelligente lettura del divario esistente tra uomini e donne quando posti di fronte ai dati che misurano livelli di istruzione e reali opportunità lavorative, bene compendiate nella prima parte del titolo del suo saggio - Crisi del merito e spreco culturale – nel quale emerge il modello vincente di “neo-tradizionalismo di genere”, così descritto: “le lavoratrici possono oggi esercitare elevati livelli di autonomia e discrezionalità in un sistema di lavoro (…) iniquo e de-professionalizzante”.
Le analisi offerte da questi contributi - non sempre da condividere in tutti i punti, ma tutte e tre ben costruite e persuasive nel loro insieme - sono di grandissima efficacia su un punto: l’obiettivo di costruire un percorso da cui emergono ordinatamente i legami e i momenti di snodo significativi tra le generazioni così da poter ricavare indicazioni socialmente utili per affrontare gli ostacoli attuali è un compito quasi impossibile da soddisfare; né corrisponde alla realtà, oggi come cento anni orsono. Ne deriva un salutare disincanto, specchio alquanto credibile delle esistenze femminili (e anche maschili naturalmente, ma una volta tanto gli uomini compaiono soprattutto sullo sfondo) che attraversano ormai più di tre generazioni; almeno così come le intendevano i sociologi che avevano introdotto il termine nel secolo scorso. Questi saggi parlano di barriere d’età abbattute, di eredità sfumate, di progetti saltati per aria in pochi anni, di ideali riveduti criticamente, del quotidiano stillicidio di incertezze. Pur lungi dall’indicare un orizzonte apocalittico, mentre forniscono una visione che certamente lascia poco spazio all’ottimismo, allo stesso tempo invitano a riconsiderare con occhio critico l’uso di categorie tradizionali nello studio del passato e a un ulteriore sforzo di autoriflessione.
Peccato manchi qualche parola per presentare autrici e autori.
Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità a oggi, a cura di Maria teresa Mori, Alessandra Pescarolo, Anna Scattigno, Simonetta Soldani, Roma, Viella, 2014, pp.403, €34.