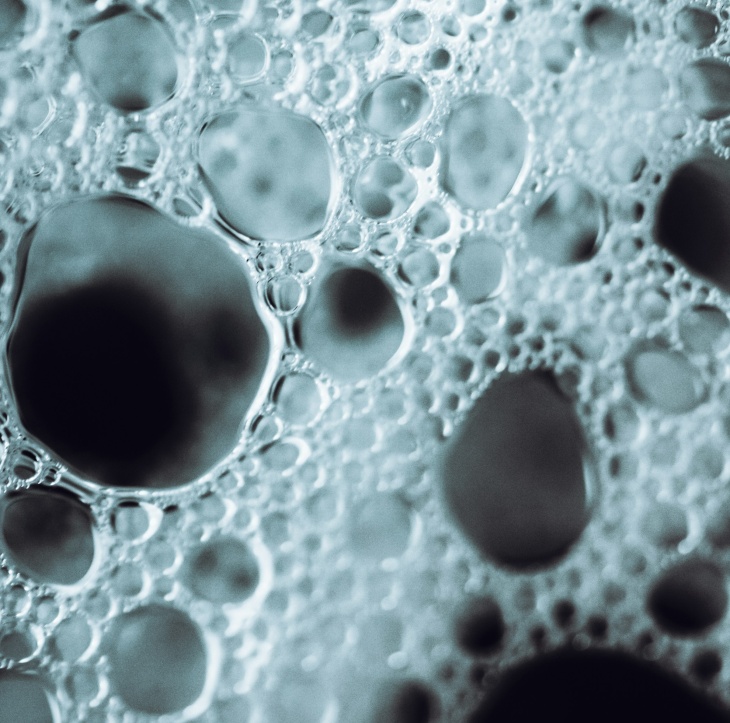Il nuovo decreto flussi non introduce nessuna norma effettiva per l'ingresso e la regolarizzazione delle lavoratrici domestiche, ancora una volta trattate come cenerentole da un sistema culturale e legislativo sempre più inadeguato a capire il paese

Non stupisce che il recente decreto flussi non preveda alcuna norma finalizzata all’ingresso regolare o alla regolarizzazione delle badanti.[1] La cosa farebbe sorridere, se non fosse per l’elevato numero di badanti che avrebbero potuto godere di tale misura. E non si dica che ci troviamo di fronte a un convitato di pietra: l’esclusione di questa categoria professionale è esplicitamente voluta e rivendicata.
Il testo conferma la perdurante neutralità di genere di un linguaggio giuridico che sembra tenace nel non tener conto della femminilizzazione di uno dei settori di impiego più rilevanti per questo paese – quello del lavoro di cura e del lavoro domestico – caratterizzato, ormai da tempo, da un crescente invecchiamento demografico e da un’economia che stenta a risollevarsi.
Entrando nel dettaglio del decreto approvato, al di là delle considerazioni che si potrebbero fare sul meccanismo irrealistico del contratto di soggiorno e dell’ingresso regolare del lavoratore straniero su chiamata del datore di lavoro – lascito illustre della legge Bossi-Fini del 2002 – è sufficiente scorrere le categorie di lavoratori a cui il decreto si rivolge ai fini dell’ingresso e della regolarizzazione, per comprendere che le badanti difficilmente potranno godere di questa seppur insufficiente misura.
Delle 30.850 unità previste dal provvedimento, 18.000 sono riservate al lavoro stagionale, 9.850 alla conversione in lavoro dei permessi di soggiorno per altro titolo (ad esempio per lavoro stagionale, per studio o formazione, permessi di soggiorno di lungo periodo), 3.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo.
Se si esclude il lavoro autonomo (2.400 quote), l’unica categoria prevista dal decreto che sembrerebbe interessare le badanti concerne gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (600 quote). E tuttavia, 500 di queste sono riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d'origine.[2]
Rimangono dunque 100 quote annuali per lavoro subordinato che, da decreto, vengono però riservate a lavoratori e lavoratrici stranieri di origine italiana provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Forse, tra queste 100 quote qualche badante potrebbe anche rientrarci.
L’indifferenza bipartisan nei confronti delle lavoratrici domestiche si accompagna alla scarsità di studi specifici sul tema, nonché all’inadeguatezza di dati disaggregati per genere relativi al lavoro domestico in Italia. Dati che fanno principalmente riferimento – come nel caso dell’Osservatorio sui lavoratori domestici Inps – alle persone assunte con regolare contratto di lavoro. Eppure, studi internazionali – ma anche italiani, sebbene in numero minore – segnalano la pressante urgenza di una miglior regolazione di questo settore del mercato, in cui si addensano sacche crescenti di irregolarità e sfruttamento.
Secondo un policy brief dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) del 2015, l’80% dei collaboratori domestici sono impiegati in paesi ad alto reddito (9,1 milioni degli 11,5 milioni stimati).
Una ricerca dell'Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico (Domina) del 2017 – realizzata dalla Fondazione “Leone Moressa” – stima che i lavoratori domestici in Italia ammontano a 1,6 milioni di cui 830.000 sono impiegati – anche irregolarmente – come badanti, con un contributo al Pil italiano pari a 18,96 miliardi.
Sempre nel 2017, la spesa delle famiglie italiane per il lavoro domestico di colf e badanti era pari a 6,9 miliardi. Considerando che nel 2015 gli anziani ospitati in strutture residenziali erano circa 278 mila per una spesa pro-capite di 18.957 euro per anziano ospitato, il report tenta una stima della spesa aggiuntiva che graverebbe sullo stato nel caso le famiglie diminuissero il loro impegno nel lavoro domestico: “se le 830 mila assistenti familiari in Italia cessassero di lavorare per le famiglie, lo stato avrebbe 830 mila anziani in più da collocare nelle strutture. Oltre a un problema logistico e di personale, dovrebbe far fronte ad una spesa aggiuntiva di circa 15 miliardi di euro”.
Per quanto riguarda le condizioni di impiego nel settore, sono le caratteristiche stesse del lavoro domestico a prestare il fianco a rilevanti sacche di lavoro irregolare: le mansioni di badante sono svolte prevalentemente nell’ambito domestico o meglio nella casa del datore o della datrice di lavoro. Inoltre, gli orari di lavoro sono spesso estremamente flessibili e difficilmente quantificati con precisione e il carico di lavoro può variare notevolmente in base alle esigenze di cura della persona assistita.
Secondo l'associazione Domina, le condizioni strutturali di questo tipo di occupazione sono causalmente collegate all’irregolarità dell’impiego, sia nel senso di lavoro nero (senza un contratto di lavoro), sia di lavoro grigio (il numero di ore di lavoro effettivo è maggiore rispetto a quelle dichiarate). L’irregolarità dell’impiego, oltre a costituire un vulnus ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ha anche un costo per le casse statali: citando ancora la ricerca Domina, se le famiglie spendono per i lavoratori domestici regolari 900 milioni di euro annui (1.016 pro-capite), possiamo calcolare il mancato gettito per i 735 mila irregolari stimati dallo studio pari a 747 milioni di euro annui.
A questo quadro si aggiunge l’elemento della crisi economica: da un’indagine condotta da Acli-colf infatti, emerge che il 41,7% delle intervistate ha evidenziato che, con la crisi economica, è molto più difficile farsi assumere con un contratto totalmente o parzialmente regolare, mentre il 44,3% delle intervistate si dichiara molto d’accordo con l’affermazione secondo cui negli ultimi anni le famiglie chiedono di lavorare più ore senza aumentare però la paga.[3]
Infine, come evidenzia uno studio commissionato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nel 2017, il sistema di welfare italiano e le politiche migratorie in vigore da anni nel paese contribuiscono fortemente al perpetrarsi dello sfruttamento in ambito domestico: in Italia il crescente bisogno di lavoro di cura derivante dall’invecchiamento della popolazione ha fatto il paio con un sistema di welfare carente e prevalentemente delegato alle famiglie, e quindi alle donne, ma si associa anche alla pressoché totale assenza di canali legali di immigrazione e di regolarizzazione della popolazione straniera irregolare, chiaramente funzionale al mantenimento di alti livelli di sfruttamento e ricattabilità della manodopera proveniente da paesi esteri.
In un’ottica di genere, l’opportunità di riprendere le fila di un discorso sul lavoro domestico che visibilizzi le condizioni di sfruttamento delle lavoratrici e richieda la regolarizzazione e la tutela delle condizioni di lavoro, si impone anche alla luce della considerazione che spesso il lavoro di queste donne costituisce la condizione essenziale e necessaria per l’uscita almeno parziale delle italiane dalla sfera domestica e di cura: lavoro di cura che viene, nei fatti, delegato ad altre donne, come evidenziato da tempo dalla copiosa letteratura in materia.
Uno studio della Fundamental Rights Agency (FRA) del 2018 – che su inGenere abbiamo già commentato – mostra come le donne impiegate nel settore di cura domestica siano esposte ad alti livelli di sfruttamento e ricattabilità a causa della loro condizione di straniere irregolari – condizione che condividono in generale con la popolazione straniera, si pensi al caso della manodopera stagionale in agricoltura – ma anche a episodi ricorrenti di abuso e violenza subiti in quanto donne. Sono i datori di lavoro a perpetrare tali violenze, facendo spesso leva sulla dipendenza economica e legale di queste donne e sul loro bisogno di guadagnarsi da vivere per sostenere se stesse e le loro famiglie nei paesi di origine. La paura della deportazione, l’assenza di controlli sulle condizioni di lavoro, la percepita o reale impunità del datore di lavoro, compongono il resto del quadro di sfruttamento a cui le lavoratrici sono sottoposte.
L’analisi della realtà strutturale della violenza di genere in una società patriarcale non può non essere applicata anche a questo ambito: le lavoratrici domestiche – in quanto donne e in quanto straniere – incarnano una molteplicità di fattori di oppressione e sfruttamento che condizionano il loro benessere fisico e psicologico nel lungo termine.
Una recentissima inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera in vista delle prossime elezioni europee, racconta della “Sindrome Italia”, una condizione di disagio psicologico sviluppato da tantissime impiegate in ambito domestico in Italia che poi decidono di ritornare in Romania: ansia, depressione, insonnia, ideazione suicidaria sono solo alcune delle componenti del disagio espresso.
Un quadro di estrema necessità e urgenza, per usare due categorie abusate nella recente prassi legislativa. Eppure, l’assenza di considerazione nei confronti di questo tema da parte del presente governo – come di quelli precedenti – è assoluta. La recente normativa sul reddito di cittadinanza ha respinto un emendamento che avrebbe permesso di includere le famiglie tra i datori di lavoro potenzialmente beneficiari di un bonus per l’assunzione di un disoccupato, titolare del sussidio appena introdotto (art. 8). Richiesta che era stata, invece, esplicitamente avanzata dall’Assindatcolf – l’associazione che riunisce i datori di lavoro domestico – durante un’audizione al Senato. L’ennesima occasione persa per ridurre le sacche di lavoro nero e grigio nel settore.
Per tornare al punto iniziale, già il 21 novembre dello scorso anno, durante un “question-time” alla Camera dei deputati, il ministro dell’interno Matteo Salvini venne interrogato dalla deputata del Partito democratico Lisa Noja, in relazione alla carenza di personale per l’assistenza familiare e alla necessità di abbattere il crescente lavoro nero che colpisce le badanti. Il ministro – anche in quel caso – propose una soluzione in salsa nazional-sovranista, ricordando che “con 3 milioni di italiani disoccupati e altri 3 milioni di italiani inoccupati che farebbero volentieri la badante domani mattina, se normalmente retribuita, penso che occorra aiutare prima questi milioni di italiani rispetto ad aiutare tutto il resto del mondo”.
Questa affermazione – perfettamente coerente con la retorica razzista del “prima gli italiani” e con l’immaginario misogino e familista di frequente proposto da vari esponenti del governo in carica – fa sorgere spontanea una serie di domande. Anche le persone italiane disoccupate di sesso maschile sono disposte a fare le badanti da domani mattina? Quale dovrebbe essere il salario per convincerli a svolgere mansioni considerate così lontane dalle “naturali attitudini” maschili?
E le donne, invece – ancora principali depositarie di tutti gli oneri di cura nella sfera domestica – sarebbero disposte a svolgere tali mansioni anche nelle case altrui? Quante famiglie sarebbero in grado di sostenere i costi di questo lavoro di cura?
Al di là di ogni retorica, lo stato sarebbe davvero disponibile a coprire la differenza tra il salario richiesto dai e dalle badanti e quello che le famiglie riuscirebbero effettivamente a pagare?
Ammesso che qualcuno sia interessato davvero a porre tali domande, il Salvini di turno sarebbe in grado di rispondere?
Note
[1] Approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2019 e pubblicato il 9 aprile in Gazzetta Ufficiale. Si veda il documento sul sito del governo e la relativa circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[2] Ex. Art. 23 del Testo Unico in materia di immigrazione
[3] Picchi, S. (2017), “Il lavoro domestico e di cura e il ruolo dei lavoratori domestici stranieri in Italia e in Europa”, in IDOS, “Dossier Statistico Immigrazione 2017”.
Leggi anche