5 ore e 35 minuti al giorno, contro le 2 ore e 16 minuti dei maschi. Le donne italiane sono primatiste del lavoro domestico non pagato, che siano casalinghe o no. E quando i figli crescono le cose non migliorano. Un'analisi aggiornata dei dati europei
Le donne italiane, più delle altre donne europee, svolgono giornalmente molte ore di lavoro domestico non pagato per la loro famiglia, sia che siano casalinghe, sia che siano occupate.
L’evidenza comune a tutti i paesi europei è che sono le donne a svolgere il lavoro domestico in misura assai superiore agli uomini, ma con notevoli differenze secondo la tipologia della famiglia, delle altre attività svolte e del paese in cui vivono. Le tradizioni culturali, che hanno storicamente forgiato i diversi modelli di organizzazione della famiglia, l’istruzione, i salari, il reddito, la politica, il governo dell’economia, sono tutti elementi che concorrono a determinare le scelte riguardanti il modo di impiegare il tempo e di suddividerlo tra attività lavorative e ricreative. Conviene cominciare dall’aspetto più generale e descrittivo, quello della dimensione del lavoro domestico.
Come si distribuisce il lavoro dei genitori
I dati dell’Eurostat1 permettono di conoscere l’ammontare di tempo dedicato al lavoro domestico non pagato in diversi paesi europei. Si tratta sia di attività svolte per tutta la famiglia - pulire, cucinare, lavare, stirare, fare la spesa, eseguire riparazioni – sia di attività specifiche di cura - accudire e badare i figli, parlarci, insegnargli, e accompagnarli.
La presenza di figli, specialmente se molto piccoli, aumenta notevolmente il lavoro domestico. Come emerge dalla Tabella 1, che mostra il tempo impiegato nel lavoro domestico delle donne per età della persona più giovane, sono i figli molto piccoli ad assorbire tanto tempo materno. Vi sono poi le differenze tra paesi. L’Italia spicca per il primato nel lavoro domestico (8 ore al giorno per i figli neonati!), seguita da Polonia e Spagna. Inoltre, in Italia il carico di lavoro domestico non diminuisce tanto quanto negli altri paesi all’aumentare dell’età della persona più giovane e le donne continuano a lavorare molte ore. I paesi in cui le ore di lavoro domestico diminuiscono di più quando la famiglia è composta solo da persone adulte sono i Paesi Scandinavi e il Regno Unito. Anche Francia e Germania hanno risultati più “virtuosi” rispetto all’Italia.
Queste osservazioni tendono a far pensare che forse le donne italiane non soffrano solamente della scarsità di servizi alla prima infanzia2, ma che il problema sia più complesso e che a scarseggiare siano anche altri servizi essenziali, come ad esempio i trasporti (molto tempo è dedicato ad accompagnare figli e altri membri della famiglia in auto). Inoltre, con l’invecchiamento della popolazione, aumenta sempre di più il tempo dedicato alla cura degli anziani, mentre la risposta pubblica a bisogni di questo tipo ancora è in fase sperimentale.
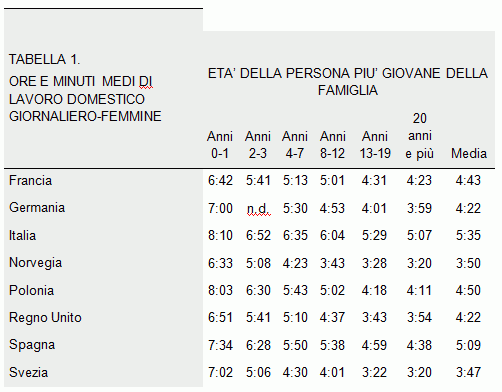
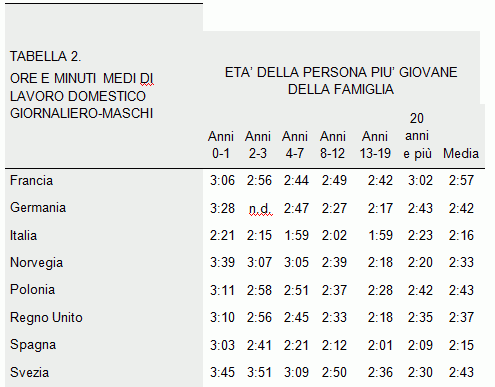
Fonte: HETUS. Indagini nazionali sull’uso del tempo armonizzate da Eurostat (anni diversi per ogni paese per un anno compreso tra il 1998 e il 2003). Popolazione di età compresa tra 20 e 74 anni. Valori calcolati su coloro che svolgono lavoro domestico. Le attività di lavoro domestico rilevate sono: cucinare, lavare, stirare, fare la spesa, riparare; curare i figli fisicamente, insegnargli, accompagnarli, parlarci, controllarli.
La scarsità dei servizi, combinata con salari femminili relativamente bassi – rispetto ai maschi e anche a molti altri paesi europei - aumenta il costo della scelta di lavorare fuori di casa, specialmente quando bisogna pagare collaboratori familiari per i servizi domestici.
Un altro importante elemento su cui riflettere è la distribuzione del lavoro domestico, influenzata in modo esasperato in Italia non solo dalla divisione dei ruoli fra genitori, ma anche fra generazioni conviventi, poiché i figli adulti in casa svolgono relativamente molto meno lavoro domestico di quanto ne creino3. La Tabella 2, riporta per i maschi le stesse informazioni fornite per le femmine nella Tabella 1. La differenza fra maschi e femmine è notevole, specialmente quando i figli sono molto piccoli.
Prendendo di nuovo ad esempio il lavoro domestico in presenza di neonati risulta che in tutti i paesi l’ammontare di ore necessario, sommando le ore di femmine e maschi nelle Tabelle 1 e 2, è di circa 10 ore giornaliere. Si può ipotizzare che quelle ore siano proprio richieste ai genitori, perché è l’ammontare normale, anche in paesi nei quali si potrebbe ricorrere a servizi per l’infanzia più diffusi dei nostri. Tuttavia, nel caso italiano c’è una differenza notevole, poiché i maschi prestano, in confronto con gli altri europei, l’ammontare più basso di ore di lavoro domestico. Ciò non dovrebbe accadere, anche perché la legge 53/2000 prevede la possibilità di congedi parentali ai padri come alle madri. Ci si potrebbe chiedere allora se la legge non sia riuscita a trovare il giusto incentivo al superamento di una così radicata divisione dei ruoli.
Il caso della famiglia composta esclusivamente da persone maggiori di 20 anni (penultima colonna delle Tabelle 1 e 2) riserva per l’Italia ancora sorprese. Il numero totale di ore fornito in media è approssimativamente uguale in tutti i paesi, un po’ meno nei Paesi Scandinavi e nel Regno Unito dove è meno probabile che i figli rimangano in casa dopo i 20 anni. La differenza di genere si riduce, ma l’Italia raggiunge il massimo di 2 ore e 40 minuti a sfavore delle femmine, seguita solamente dalla Spagna con 2 ore e 30 minuti circa. In tutti gli altri paesi la differenza è invece consistentemente al di sotto delle 2 ore.
Questa semplice descrizione genera molti interrogativi sui quali riflettere. Questo primato italiano è l’altra faccia della bassa partecipazione al mercato del lavoro delle donne italiane? Le donne italiane scelgono di fare le casalinghe oppure sono costrette a farlo perché lavorare fuori di casa non è per loro conveniente? A questo interrogativo hanno risposto tanti studiosi4 e i risultati sembrano convergere verso la seconda alternativa. Allora, dati sull’uso del tempo alla mano, è possibile fare un altro passo di tipo descrittivo: guardare alle differenze tra donne casalinghe e donne occupate.
Casalinghe e occupate
Questo calcolo, senza tener conto della composizione della famiglia5, mostra che, in Italia, le donne che svolgono lavoro pagato fuori di casa a tempo pieno lavorano di più delle casalinghe. Dalla Tabella 3 emerge che questo si verifica in tutti i paesi considerati, però le donne italiane occupate a tempo pieno non perdono il primato del lavoro domestico. Inoltre detengono anche quello della maggiore differenza nel lavoro totale fra maschi e femmine, un’ora in più per le donne, che per una media così generale non è poco. Le donne italiane, però, lavorano fuori di casa minimo 20 minuti meno al giorno rispetto alle altre europee.
Circa la distribuzione del lavoro domestico fra maschi e femmine, si potrebbe giustificare il minor impegno dei maschi italiani se il loro carico di lavoro nel mercato fosse superiore a quello degli altri europei. Così non è: la Tabella 3 mostra che i maschi italiani non lavorano mediamente di più degli altri maschi europei.
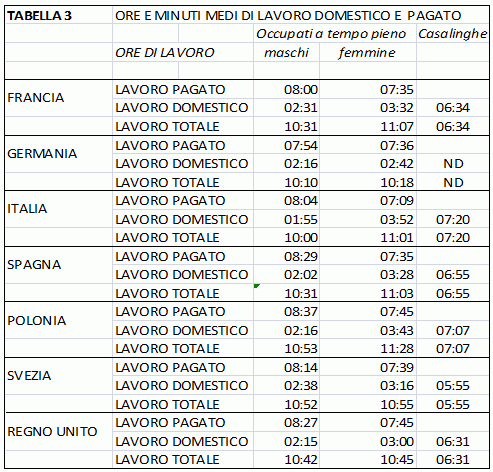
Fonte: HETUS. Indagini nazionali armonizzate da Eurostat (anni diversi per ogni paese per un anno compreso tra il 1998 e il 2003). Popolazione di età compresa tra 20 e 74 anni. Valori calcolati su coloro che svolgono lavoro.
Conclusioni
Se crediamo nel principio di razionalità delle scelte, non dovrebbe sorprendere la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro delle donne italiane. Pochi servizi e un’iniqua distribuzione del lavoro domestico tra membri familiari non possono che rendere questa una scelta molto diffusa.
Quale ruolo possono avere le politiche sociali ed economiche? Un ruolo molto importante, che dovrebbe andare nella direzione nuova di favorire un modello di famiglia dual earner-dual carer6, in cui il lavoro domestico sia equamente distribuito, in cui il tempo speso ad accudire i figli piccoli possa acquistare maggior valore se condiviso fra genitori, in cui si possano aiutare coloro che curano la famiglia ad accompagnare questa attività con un lavoro retribuito, in cui si possa raggiungere una maggior eguaglianza nel mercato del lavoro.
Note
1 I dati nelle tabelle sono estratti da Harmonized European Time Use Surveys (HETUS) che raccoglie informazioni su come le giornate delle persone sono scandite grazie all’uso di diari in cui gli intervistati registrano, nell’arco della giornata, l’ammontare in minuti del tempo dedicato ad ogni singola attività.
2 Ben documentata per l’Europa da vari studi fra i quali J. Plantenga. e C. Remery (2008), “The provision of childcare services - A comparative review of thirty European countries The co-ordinators’ synthesis report prepared for the Equality Unit”, European Commission, July 2008.
3 Sulla permanenza dei figli adulti nelle famiglie italiane si veda G.C. Giannelli e C. Monfardini (2003), “Young people living with their parents: the gender impact of co-residence on labour supply and unpaid work”, in Unpaid Work and the Economy- A gender analysis of the standards of living, a cura di A. Picchio, Routledge, ch. 7, pp 171-88.
4 Soprattutto usando informazioni sulla partecipazione e occupazione delle donne ricavate da indagini campionarie sulle famiglie. Studi specifici sulle ore di lavoro domestico sono invece pochi e recenti. Si veda, per esempio, Voicu, B., e M. Voicu (2007), "Engendered housework. A cross-european analysis", IRISS Working Paper Series, No. 7.
5 Quindi sottostimando il lavoro delle donne con figli, poiché nella media sono incluse anche quelle senza.
6 Si veda J. Gornick e M. Mayers (2009), Gender Equality: Transforming Family Divisions of Labor, Versus Books, London.










