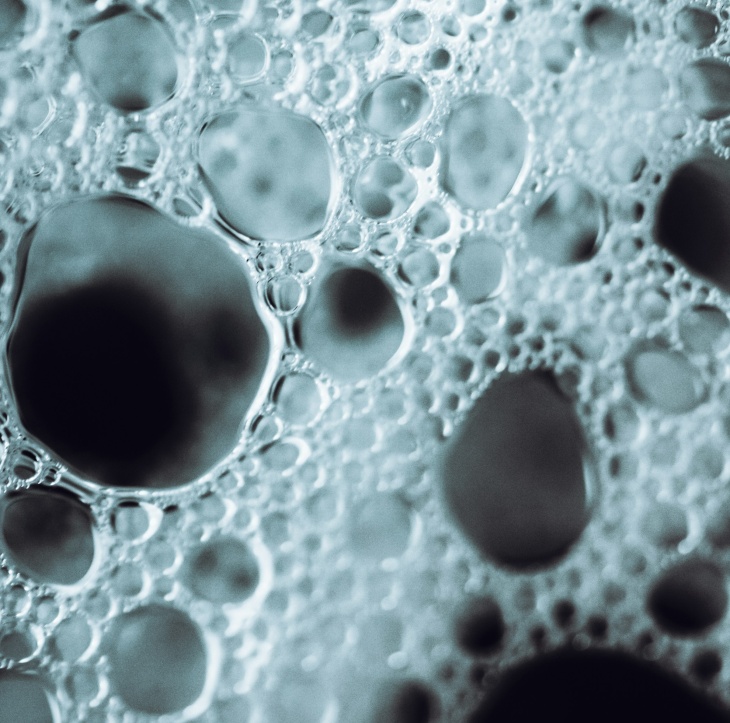Le storie delle donne detenute all'interno dei Centri di identificazione ed espulsione ci spiegano perché uno sguardo di genere è così importante per comprendere le migrazioni e sviluppare politiche adeguate

Sono passati tre anni e due mesi dal tragico naufragio a poche miglia dall’isola di Lampedusa nel quale circa 400 persone hanno perso la vita mentre tentavano di raggiungere la “fortezza Europa”. Una "fortezza" che, attraverso politiche di controllo della mobilità e moltiplicazione delle frontiere, continua incessantemente a mietere vittime. Basti pensare che nel 2016 già 3.637 persone hanno perso la vita in mare [1]. Queste persone [2] sono vittime di frontiere disegnate per non permetterne a tutti/e un attraversamento in condizioni di sicurezza.
La grande maggioranza di queste persone, scappando da guerre, violenze e persecuzioni nei loro paesi di origine, hanno diritto a ricevere protezione internazionale. Tra loro, molte, è risaputo, sono donne (circa il 28%)[1]. Nonostante spesso il discorso mediatico si sia concentrato su di loro, sovraesponendo la loro condizione di presunta “vulnerabilità”, scarso è stato il reale interesse per ascoltare quello che queste donne effettivamente ci raccontano.
Nei paesi di origine queste donne soffrono spesso abusi e violazioni dei diritti umani di genere, trovandosi a lottare contro norme sociali che minano il loro diritto a libertà e autodeterminazione. Conflitti familiari a causa della sovversione dei ruoli di genere tradizionalmente intesi nei contesti culturali e religiosi di appartenenza, violenza di genere e situazioni di estrema povertà in cui l’onere del sostegno è delegato alle donne sono tra i motivi più comuni dietro alla decisione di cambiare paese. La migrazione diventa quindi il risultato delle lotte delle donne contro le oppressioni sperimentate nei contesti di origine. Come osservano Turan e colleghe[4] “la migrazione può essere una 'scelta', una espressione di agentività. Ma anche quando forzata, la migrazione è spesso il risultato di un atto di resistenza da parte della donna, e così dovrebbe essere analizzata all’interno del più ampio contesto strutturale”. Un atto intrapreso non solo per sopravvivere, ma anche “per preservare la propria dignità ed espandere le proprie scelte di vita” [4].
Durante il percorso migratorio, specie per coloro che provengono dall’Africa Sub-Sahariana attraverso il Niger e la Libia, queste donne sono esposte allo stupro in maniera che potremmo definire sistemica. Il loro corpo diventa moneta sonante per il pagamento dei passeurs, oggetto di possesso per i gestori delle varie ‘connection houses’ in cui fanno tappa, prezzo di scambio nei luoghi di raccolta prima del viaggio verso l’Italia/Europa. Usando le parole di Camille Schmoll, tali viaggi sono “esperienze corporee di una frontiera senza fine che si reitera in differenti luoghi e momenti”[5].
Nei paesi di arrivo gerarchie e prescrizioni di genere continuano a condizionare fortemente la vita delle donne migranti, che è spesso marcata da violenza e marginalizzazione. Come sottolinea l’ultimo Rapporto Istat sulla violenza contro le donne, le donne straniere sono infatti più esposte di quelle italiane alla violenza fisica (25,7% vs. 19,6%) e a stupri o tentati stupri (7,7% vs. 5,1%).
Nell’ambito della mia ricerca sulla vita all’interno dei centri di detenzione per migranti in Italia e in Portogallo, la mia attenzione, da femminista, si è rivolta proprio alle donne e a come il genere influenza le loro esperienze di migrazione e, soprattutto, di confinamento. Non è strano rilevare che poco si sa delle esperienze di queste donne. A parte rari studi accademici[3, 6, 7] e qualche rapporto prodotto dal mondo dell’associazionismo femminista (vedi il rapporto Inter/rotte: storie di tratta, percorsi di resistenze a cura della cooperativa BeFree), le voci delle donne migranti in condizione di detenzione sono rimaste perlopiù inascoltate. Ciò si inscrive all’interno di un più ampio processo storico di esclusione delle donne dal processo di produzione della conoscenza attuato attraverso il silenziamento delle nostre voci e l’invisibilizzazione delle nostre esperienze [8].
Avendo trascorso molto tempo nel Centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Ponte Galeria a Roma in compagnia delle donne lì trattenute, chiacchierando e intervistando molte di loro, mi è risultata evidente la natura razzializzata e genderizzata delle loro esperienze e, in particolare, della violenza a cui sono esposte. Tale violenza è di fatto un file rouge che attraversa le loro storie, nei paesi di origine, di transito e di arrivo. Al tempo stesso però queste donne non sono inscrivibili in una mera categoria di "vittime passive", come spesso il discorso politico-mediatico tenta di fare, bensì lottano con tutti i mezzi a loro disposizione per resistere a tale violenza e sovvertire l’ordine loro imposto. Oppressione e resistenza, vittimizzazione ed agentività, si palesano nelle loro esperienze di vita come dimensioni profondamente interconnesse nonché influenzate dalle realtà strutturali che fanno da cornice alle loro storie.
Nonostante la violenza di genere sia un denominatore comune nelle esperienze delle donne trattenute nel Cie di Ponte Galeria, nella maggioranza dei casi questa non è denunciata per paura di essere trattenute e deportate nei propri paesi di origine in quanto migranti "irregolari". Tale paura, di fatto veritiera - dato che spesso le donne che si recano alle forze dell’ordine per denunciare invece di essere protette sono condotte al Cie per essere identificate e deportate - e la vulnerabilità legata al loro status migratorio sono usate da partner e datori di lavoro per imporre abusi, violenze e sfruttamento, restando impuniti. Pur non potendo avvalersi dei dovuti dispositivi di protezione, le donne lottano per resistere a tali oppressioni, avvalendosi di altre risorse/strategie, facendo ad esempio ricorso al supporto di familiari e amiche.
Se il genere influenza trasversalmente le traiettorie di vita delle donne, giocando un ruolo sia nelle cause che nelle conseguenze della loro migrazione, questo incide anche sulle pratiche e sulle istituzioni coinvolte nel processo di controllo e gestione della loro migrazione. Istituzioni queste ultime che, come nel caso dei centri di detenzione, contribuiscono attivamente a costruire e mantenere le gerarchie razziali e di genere della società tutta.
Una volta in Italia le donne, trattate come migranti irregolari, sono private dei diritti fondamentali ed escluse dal diritto di cittadinanza. Così i loro corpi diventano invisibili e negati, sottoposti a una doppia violenza, quella maschile e quella dello stato, esercitata con la privazione della libertà su base amministrativa e nel rischio di deportazione forzata.
Come afferma Gabriella Alberti[3] il regime detentivo è genderizzato e in quanto tale agisce per riprodurre la vulnerabilità delle donne migranti e silenziare le loro voci in quanto soggettività politiche. In linea con le norme patriarcali, all’interno del Cie le donne sono divise in "buone" e "cattive": le prime sono quelle che non creano problemi allo staff e che si prestano ad essere incasellate nella nozione egemonica di una femminilità docile e sottomessa, mentre le seconde sono le "insubordinate", più difficili da gestire e le cui identità trasgrediscono i ruoli tradizionali di genere - ad esempio le lavoratrici sessuali e le donne con esperienza di incarcerazione. Resistendo all’oggettificazione messa in atto dal sistema detentivo, le donne lottano per affermare la propria soggettività politica nonché le proprie auto-narrazioni.
Tutte, seppur in maniera diversa, rivendicano un unico diritto, quello alla libertà. È proprio la rivendicazione di tale diritto che ha mosso le proteste succedutesi negli anni nei vari Cie in Italia. Proteste i cui protagonisti non sempre sono stati uomini: a tal proposito è importante ricordare la protesta nata nell’agosto del 2011 nella sezione femminile del Cie di Bologna contro la legge 129 del 2011, che estendeva il termine massimo di detenzione nei Cie da 6 a 18 mesi. Questo, così come altri episodi di vita quotidiana all’interno dei centri, mostrano l’importanza della solidarietà tra donne contro l’ingiustizia delle politiche migratorie contemporanee.
Una solidarietà che è importante pensare e agire anche da fuori, dando spazio e ascolto alle voci di queste donne, le uniche in grado di sfidare l’egemonia del discorso securitario sulla migrazione - di cui i Cie sono il prodotto - e decostruire la storia unica di cui parla la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Una solidarietà che deve passare attraverso la condivisione di un progetto politico che abbia al centro l’apertura delle frontiere e l’abolizione dei centri di detenzione.
Riferimenti
[1] UNHCR, Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean, 2016
[2] Sono definite i/le nuovi/e "desaparecid@s, asesinad@s y muert@s", vedi Stephen L., Los nuevos desaparecidos y muertos. In security disarmed: critical perspectives on gender, race, and militarization, ed. Barbara Sutton, Sandra Morgen, and Julie Novkov, 79-100. New Jersey: Rutgers University Press, 2008
[3] Alberti G., "Across the borders of lesvos: the gendering of migrants' detention in the Aegean", Feminist Review, 94, pp. 138-147, 2010
[4] Turan J.M., Hatcher A.M., Romito P., Mangone E., Durojaiye M., Odero M., and Camlin C.S., “Intimate partner violence and forced migration during pregnancy: structural constraints to women's agency.” Global Public Health 11(1-2), pp.153-168, 2016
[5] Schmoll C., “Gendered spatialities of power in ‘borderland’ Europe: an approach through mobile and immobilised bodies”, Internation Journal of Migration and Border Studies 1(2), pp. 173-189, 2014
[6] Bosworth M.F., Andriani and Pickering S., “Women's immigration detention in greece: gender, control, and capacity", in Immigration Detention, Risk and Human Rights, ed. Maria João Guia, Robert Koulish, and Valsamis Mitislegas, pp. 157-170, New York: Springer, 2014
[7] Bosworth M., Blerina K., “Citizenship and belonging in a women's immigration detention centre”, in New directions in race, ethnicity and cime, ed. Coretta Philips, and Colin Webster, pp. 80-96. Abingdon: Routledge, 2014
[8] Langton, R., "Feminism in epistemology: exclusion and objectification", in The Cambridge companion to feminism in philosophy, ed. Miranda Fricker and Jennifer Hornsby, pp. 127–145, Cambridge: Cambridge University Press, 2000