Ogni scienziato con formazione di alto livello ci costa 500 000 euro, che poi regaliamo ad altri paesi. Esportiamo talenti e non riusciamo ad attrarne: l'European Research Council ha assegnato 312 borse, ma un solo ricercatore straniero ha scelto un'istituzione italiana per svolgere i suoi studi. Andiamo a vedere chi ha vinto le borse e dove ha deciso di svolgere la propria ricerca.
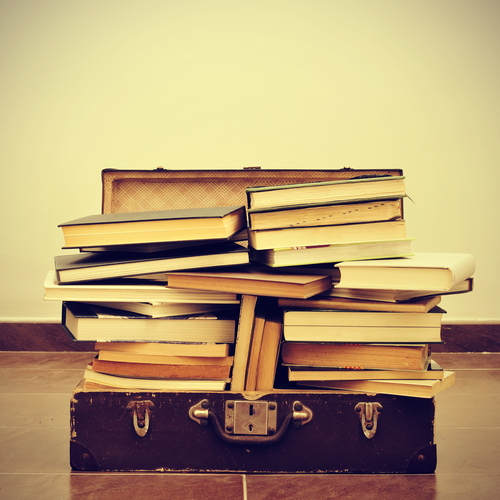
Il 14 gennaio l'European Research Council (il Consiglio europeo della ricerca), la prima agenzia dell'Unione europea dedicata al supporto della ricerca scientifica, ha assegnato 312 grants, borse di studio riservate a ricercatori in una fase intermedia della loro carriera (da 7 a 12 anni dopo il conseguimento del dottorato).
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la ricerca, l’innovazione e la scienza, ha dichiarato: «Questi ricercatori percorrono strade innovative che faranno avanzare la conoscenza e apporteranno un contributo concreto nella società. Il Consiglio europeo della ricerca offre loro assistenza in una fase cruciale, in cui è spesso difficile reperire finanziamenti: quando hanno bisogno di spingersi avanti nella carriera sviluppando la loro propria ricerca con la loro squadra».
La buona notizia è che tra i vincitori, ben 46 tra ricercatori e ricercatrici sono italiani, solo due in meno della Germania e parecchi di più di Francia, Inghilterra, Olanda e tutte le altre. Una notizia che inorgoglisce, ma soprattutto che fa ben sperare, per un Paese in cui le classi dirigenti hanno mortificato l’istruzione in generale e la ricerca in particolare, e dove nonostante tutto si producono eccellenze che da sole basterebbero a indicare la via per uscire da questa crisi.
L’Italia si colloca dunque al secondo posto per numero di grant assegnati ma, e qui arriva la cattiva notizia, meno della metà di quei ricercatori scelgono l’Italia per svolgere la propria attività. E, soprattutto, solo un ricercatore di un altro paese sceglie un’istituzione italiana. Peccato, perché per formare quelle eccellenze, per formare un/a scienziato/a di quel livello, spendiamo ben 500.000 euro ciascuno, e poi, con la buona pace dei tanti professori che su questo si sono espressi, gli consigliamo persino di andare all’estero, perché nel nostro paese non ci sono possibilità. Ne ricordo uno su tutti (per non sembrare vanamente polemica): Pierluigi Celli e la sua lettera al figlio.
Inoltre non siamo capaci di attrarre risorse dagli altri paesi, il che conferma come il nostro sia ormai un paese da cui emigrare, con buona pace di chi spende tempo ed energie a trovare il modo per limitare l’immigrazione. Ma torniamo ai grants e alla loro importanza anche dal punto di vista economico, argomento che dovrebbe interessare le nostre classi dirigenti, sempre alla ricerca dei fondi mancanti e sempre pronte a fare spallucce quando gli si domanda perché ad un Ministero come quello dell’istruzione e della ricerca si continua a tagliare senza tregua.
Si tratta infatti di progetti piuttosto onerosi, si arriva a un finanziamento massimo di 2,75 milioni di euro, per una media di 1,84 a progetto. E un totale di 575 milioni di euro di finanziamento. Cioè i 26 italiani che non faranno il loro grant in un’istituzione scientifica italiana molto probabilmente già lavorano all’estero, e fanno parte di quella "legione straniera" che – anno dopo anno – ingrossa le propria fila e, evidentemente, impoverisce il nostro paese.
Non è consolatorio spendere centinaia di migliaia di euro per formare un/una giovane scienziato/a per regalarlo alla Germania. Ogni anno ci sono centinaia di giovani che emigrano a fare ricerca altrove, e ogni 3 o 4 di loro è 1 milione di euro in costi di formazione che buttiamo via, anzi molto di più tenendo conto del ritorno in termini economici che va al paese che li accoglie.
Più della metà degli scienziati italiani che sono in grado di competere per fondi europei per progetti importanti sono già all’estero. E questo significa anche che abbiamo impoverito il sistema della ricerca nazionale, ma anche l’università, rinunciano agli elementi migliori, ovvero quelli che probabilmente avrebbero potuto dare continuità al sistema che li ha formati. Questo può voler dire che, se continuiamo così, tra dieci anni non ne avremo poi tanti di quelli bravi, a insegnare nelle nostre università.

Infine, guardando alle caratteristiche dei vincitori o meglio delle vincitrici dei Grants, scopriamo che l’Italia vanta il maggior numero di scienziate che si aggiudicano la borsa di studio. Infatti, se sul totale la percentuale di donne si attesta ancora al 24%, comunque in crescita rispetto all’ultimo bando (2012) della stessa categoria- in cui era attorno al 22,5%- per quanto riguarda le italiane, sono molte di più di quelle degli altri Paesi. Insomma l’Italia risulta essere quella con il maggior numero di Grants assegnati a ricercatrici. Non per merito del nostro Paese naturalmente, che penalizza le ricercatrici in campo scientifico - nei loro percorsi formativi, nelle loro carriere - come la maggior parte delle donne nel mercato del lavoro.
Sulla disparità tra uomo e donna nel mondo della scienza ci sarebbe da aprire un’ulteriore indagine, ovviamente dipende da una serie di fattori: dal luogo, da chi dirige i centri, da quanto la materia è vecchia o nuova, dai baronati universitari, dalle fondazioni, dai soldi che girano intorno. Ma qui ci basti sollevare il problema rispetto alla ricerca in generale e rispetto al fatto che finché di queste scienziate, di queste eccellenze al femminile, non se ne parlerà, sarà difficile far introiettare modelli e obiettivi strategici differenti, per esempio alle giovani generazioni, che oggi crescono nell’assenza di una prospettiva e nella paura di non trovare una strada e un progetto di vita che possa prima o poi realizzarsi.
L’augurio invece è che il grafico di sopra e i risultati dei grants possano essere una molla per investire nella propria formazione e per le classi dirigenti, per investire nella ricerca, soprattutto al femminile.










