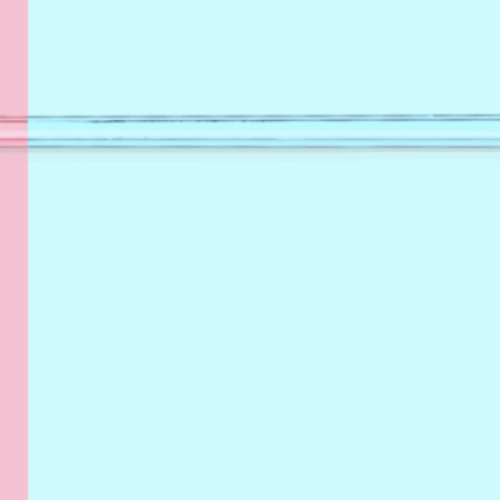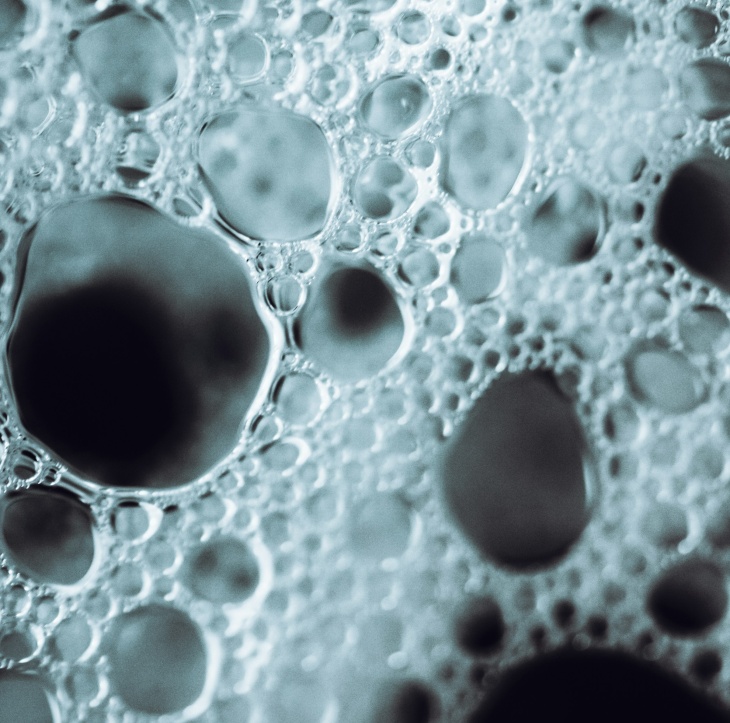Mentre a colpi di sentenze la legislazione italiana in materia di riproduzione medicalmente assistita ha fatto grandi passi avanti, l'ultimo pronunciamento del tribunale internazionale di Strasburgo evita di prendere posizione e per di più si pone in modo paternalista nei confronti delle donne
La Corte dei diritti dell'uomo,
un po' meno delle donne

Nella sentenza del 3 novembre 2011 (S.H. e altri versus Austria) la Gran camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha capovolto una precedente decisione della prima sezione e ha stabilito che il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (pma) di tipo eterologo in vitro non viola l’Articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu. In particolare, osserva la Corte, sebbene vi sia un trend generale a favore dell’utilizzo della pma eterologa, non esiste ancora un consenso consolidato tra gli stati contraenti su un tema così eticamente sensibile e pertanto spetta alle autorità nazionali operare un bilanciamento tra i diversi interessi legittimi in gioco.
La pronuncia presenta, a nostro avviso, molteplici punti critici, sia nel merito che nel metodo. Innanzitutto, la questione è affrontata esclusivamente in chiave etico-morale, senza considerare le ricadute pratiche e gli ulteriori interessi in gioco. Il legislatore austriaco, nel porre il divieto, avrebbe inteso ostacolare il formarsi di “relazioni familiari inusuali”, con la scomposizione della maternità in genetica e “gestante”, ed impedire il rischio della commercializzazione di ovuli e il conseguente sfruttamento delle donne, specie di quelle provenienti da paesi con scarse risorse economiche. Che le relazioni familiari “atipiche” possano compromettere la crescita del bambino, tuttavia, è un dato smentito da numerosi studi che hanno dimostrato come il suo benessere non dipenda dal legame biologico con i genitori bensì dalla capacità di questi di amarlo, proteggerlo e assicurargli un contesto di crescita adeguato. E ancora, sebbene i timori sul rischio di mercificazione del corpo delle donne siano condivisibili, non si comprende perché analoghe preoccupazioni non si sollevino anche per la donazione di sperma. Senza dubbio la donazione di ovociti è una tecnica invasiva e maggiormente rischiosa per le donne. Tuttavia è noto che episodi di abuso e violenze si verifichino anche nei casi in cui il donatore sia un uomo. Ignorando questo aspetto la Corte assume un atteggiamento paternalistico che rafforza stereotipi di genere veicolando un’immagine unidimensionale della donna come vittima bisognosa di protezione.
Sotto un diverso profilo, i giudici di Strasburgo sembrano, inoltre, non tener conto delle ricadute che il divieto di eterologa ha sul diritto alla salute della coppia e della donna, in particolare. L’infertilità e la sterilità, infatti, oltre ad essere patologie, sono causa di malesseri psichici e le tecniche di pma ne rappresentano il solo rimedio esperibile.
Riguardo al metodo, infine, è la costruzione dei parametri del margine di apprezzamento che non convince. La Corte si è limitata a constatare l’inesistenza di un consenso omogeneo fondato su principi univoci e stabili tra gli stati contraenti, rimettendo ogni valutazione alla discrezionalità del legislatore nazionale. Tale prospettiva, che afferma la centralità delle politiche nazionali nella gestione di problematiche eticamente sensibili, rischia di minare quel processo di progressiva armonizzazione dei diritti fondamentali di cui la Corte di Strasburgo dovrebbe essere promotrice e garante.
In direzione opposta pare (fortunatamente) muoversi l’esperienza italiana. Come in un trapianto mal riuscito, infatti, l’ordinamento nazionale sta progressivamente espellendo i residui molesti di una legge incompatibile con le istanze reali della società: la legge numero 40 del 2004. L’ultimo colpo di scure arriva dalla Corte costituzionale che con la sentenza n. 162 del 2014, a dieci anni di distanza dalla sua entrata in vigore, ha definitivamente accertato in diritto quello che per molti era di piena evidenza in fatto: il divieto di eterologa è ingiusto, irragionevole e incostituzionale. Ingiusto, perché si vieta in Italia ciò che chi ha mezzi economici adeguati può comunque conseguire altrove, così attivando un meccanismo selettivo della genitorialità fondato su parametri squisitamente economici. Irragionevole, perché fondato sull’indefettibilità del diritto all’identità genetica del nato, un diritto, tuttavia, che potrebbe comunque essere garantito a costo di un minore sacrificio, ove l’interessato ne avanzasse richiesta, così come da tempo accade nell’istituto dell’adozione. Incostituzionale, infine, perché lede il principio di eguaglianza e il diritto della coppia di proiettarsi in un progetto di genitorialità; perché ne mina la salute fisica ma anche il benessere psichico; perché in maniera del tutto irrazionale sostiene chi è affetto da patologie meno gravi, rimediabili mediante il ricorso alla pma omologa, ignorando, per contro, le istanze di cura di una disabilità permanente ed irreversibile.
Sono pagine importanti della nostra storia costituzionale il cui pregio principale sta forse nell’aver ristabilito un’accettabile prospettiva laica sul tema. L’infertilità e la sterilità, affermano con forza i giudici, non sono urgenze etiche ma temi di salute. Lo sono nella misura in cui coinvolgono quella dimensione ampia del benessere umano – il “miglior stato di sanità possibile”, nella definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità – che è un diritto fondamentale di ogni individuo, come singolo e nella coppia.
Ebbene, rileva la Corte costituzionale, nel caso di patologie produttive di una disabilità, idonee ad incidere in maniera significativa sulla salute della coppia, poiché ne frustrano il desiderio di genitorialità, il parametro di definizione dei limiti dell’intervento non può essere rimesso al capriccio etico del legislatore. L’eterologa è un trattamento sanitario e come tale va affrontato e gestito, secondo i principi generali che regolano ogni altro trattamento sanitario, nella cornice autonoma e insindacabile dell’alleanza terapeutica medico-paziente.
Così, dunque, replicano i giudici italiani alla Corte di Strasburgo: non c’è nulla da bilanciare, non c’è priorità da garantire o interesse con cui interferire. Solo il diritto di disporre liberamente del proprio corpo, di realizzare per esso un’auspicata immagine di sé.