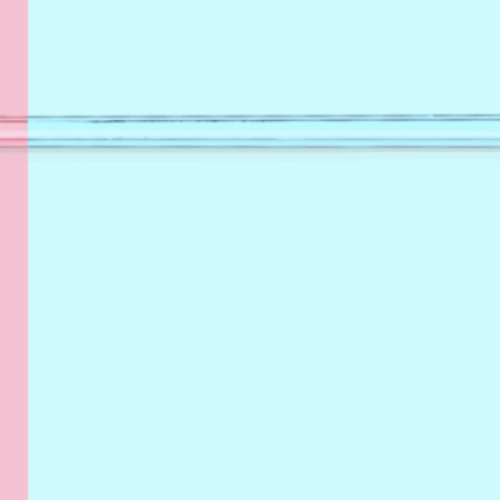Gli ultimi dati diffusi da Istat e Unar, ci consegnano la fotografia di un paese ancora alle prese con discriminazioni legate al genere e all'orientamento sessuale, che condizionano la vita delle persone sul lavoro e nello spazio pubblico
Non è un paese
per queer

Il 24 marzo Istat e Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) hanno reso pubblici i risultati della rilevazione statistica sulle discriminazioni lavorative nei confronti delle persone Lgbt+, portata avanti nel 2020-2021 nell’ambito del progetto di ricerca Discriminazioni lavorative nei confronti delle persone Lgbt+ e le diversity policies attuate presso le imprese. Il quadro che ne risulta non è affatto roseo e l’intersezionalità delle discriminazioni emerge in maniera preponderante.
Il report fornisce un quadro aggiornato delle condizioni di lavoro e di accesso al mercato del lavoro delle persone gay (65,2% del campione), lesbiche (28,9%) e bisessuali (4,2% donne e 1,7% uomini) in Italia.[1] Nella prima parte vengono delineate le caratteristiche del campione; la seconda si concentra sulle esperienze di discriminazione in ambito lavorativo; la terza, infine, riporta esperienze di discriminazione in altri ambiti della vita come, per esempio, la ricerca di una casa, l’accesso ai servizi socio-sanitari e la fruizione di servizi pubblici.
Per quanto riguarda le caratteristiche del campione, vale la pena sottolineare che nella sua quasi totalità si compone di persone con cittadinanza italiana, perlopiù uomini (66,9%), di mezza età (il 43,6% ha 50 anni o più) e che vivono nel Nord del paese (61,2%). Le donne sono in media più giovani e convivono oltre che con la partner anche con figli (il 18,9% delle lesbiche, il 23,7% tra le donne bisessuali).
Altro elemento di rilievo è il titolo di studio di chi ha partecipato alla rilevazione (il 38,8% ha conseguito almeno la laurea) e il fatto che la maggior parte del campione abbia descritto come buona la propria situazione economica. Un campione, dunque, di estrazione sociale medio-alta e, data l’età, con un inserimento pressocché stabile nel mercato del lavoro: la stragrande maggioranza di chi ha partecipato è occupata (77%) o lo è stata in passato (22,5 %) e solo una quota irrisoria non ha mai lavorato (0,5%).
Il lavoro dipendente è la modalità di impiego prevalente e il settore terziario quello più rappresentato. La segregazione orizzontale di genere compare infatti immediatamente: la componente femminile del campione è più presente in settori tradizionalmente femminilizzati quali sanità e assistenza sociale e altri servizi; gli uomini, di converso, sono rappresentati in attività quali il commercio all’ingrosso e al dettaglio, la riparazione di auto e moto e le attività manifatturiere.
Il livello generale di apertura del campione rispetto al proprio orientamento sessuale sul posto di lavoro è elevato: la maggioranza – soprattutto tra gay e lesbiche – dichiara che il proprio orientamento sessuale è noto a una parte delle persone del proprio ambiente lavorativo (92,5%), soprattutto a persone di pari grado. Tuttavia, episodi di outing – ovvero di disvelamento non consensuale con terzi dell’orientamento sessuale (o dell’identità di genere) – vengono riportati dal 32,2% di chi ha risposto.
Di assoluto rilievo il dato secondo cui una persona su cinque ritiene che l’orientamento sessuale abbia costituito un elemento di svantaggio nella vita lavorativa, soprattutto in termini di carriera, riconoscimento e apprezzamento delle proprie capacità, meno per quanto riguarda la retribuzione. Questo svantaggio sembra crescere nelle organizzazioni con molte persone e nel settore privato, mentre si riduce all’aumentare degli anni di occupazione. Inoltre, la presenza di politiche di inclusione della diversità sembra costituire un elemento positivo nel ridurre lo svantaggio.
L’aspettativa dello stigma e della discriminazione da parte delle persone Lgb disincentiva l’apertura rispetto al proprio orientamento sessuale sul posto di lavoro: il 40,3% del campione – soprattutto le donne e chi ha un lavoro dipendente – riferisce di aver evitato di parlare della propria vita privata e una persona su cinque ha dichiarato di evitare di passare il tempo libero con persone del proprio ambiente lavorativo. Una parte del campione ha, inoltre, riportato episodi di microaggressione da parte di colleghi o clienti avvenuti sul posto di lavoro e legati all’orientamento sessuale: uso di epiteti dispregiativi, domande invasive sulla vita sessuale, scherno e avance sessuali non gradite gli episodi riportati con maggiore frequenza.
Interessante evidenziare che nel 40,3% dei casi la persona non ha fatto nulla in risposta all’accaduto, denotando probabilmente l’assenza di meccanismi di tutela e supporto all’interno dell’organizzazione. Anzi, a seguito di tali episodi il 6,9% ha pensato di lasciare il posto di lavoro e il 2,5% ha deciso di farlo.
Per quanto concerne gli episodi di discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro, una persona su tre ha dichiarato di aver vissuto questa esperienza ma non necessariamente in relazione al proprio orientamento sessuale. Altri fattori vengono menzionati da chi ha risposto, quali il genere, le origini straniere, l’aspetto esteriore, eventuali problemi di salute, le convinzioni religiose o le idee politiche, ecc. A riportare episodi di questo tipo sono soprattutto le donne, le persone di origine straniera e chi ha un titolo di studio basso: in questo senso, l’intersezione tra l’orientamento sessuale, il genere, la classe e la cittadinanza o il gruppo etnico si impone con evidenza.
Le discriminazioni menzionate più di frequente nell’accesso al lavoro sono offerte di lavoro senza contratto regolare e mancata assunzione a fronte di persone candidate con caratteristiche simili. In questo ambito, le donne menzionano il proprio genere come il motivo principale del trattamento sfavorevole. Anche in questo ambito l’aspettativa di subire discriminazioni è un fattore di rilievo che ha spinto il 6,3% del campione a non presentarsi al colloquio di lavoro per paura che il proprio orientamento sessuale non sarebbe stato accettato e il 12,6% per paura di ritrovarsi in un ambiente di lavoro omo-lesbo-bifobico.
Per quanto riguarda, invece, le discriminazioni sul posto di lavoro, gli episodi menzionati riguardano gli avanzamenti di carriera, lo svilimento delle competenze e dei risultati e il mancato aumento di stipendio. Le donne, in particolare, menzionano un trattamento di svantaggio nel godimento delle misure di conciliazione, quali congedi e permessi (parentali o di altra natura). Il posto di lavoro, infine, viene descritto anche come caratterizzato da un clima ostile e da aggressioni: il campione ha fatto riferimento a calunnie, derisioni, umiliazioni, violenza verbale e offese anche di tipo sessuale. Coerentemente a quanto sopra riportato, episodi di questo tipo sono stati menzionati con maggiore frequenza dalle persone straniere, dalle donne e da chi proviene dal Sud Italia.
Infine, occorre sottolineare che l’orientamento sessuale è oggetto di discriminazioni non solo sul posto di lavoro ma in numerosi altri ambiti della vita. I dati della rilevazione sembrano confermarlo: il 16,8% delle persone ha lasciato il proprio luogo di residenza per poter vivere più tranquillamente il proprio orientamento sessuale (il 12% in un altro comune, il 3,4% all’estero). Inoltre, vengono menzionati episodi di ostilità da parte del vicinato, negli uffici pubblici, sui mezzi di trasporto e nei negozi; il 10,4%, inoltre, ha raccontato problemi nell’accesso ai servizi medico-sanitari.
Anche il tema della prole è stato menzionato in questo contesto, riportando episodi di discriminazione nel rapporto tra genitori e tra pari. Anche in questo caso, l’aspettativa e la percezione delle discriminazioni viene esplicitamente menzionata: il 71,8% del campione ritiene che le persone Lgb sia molto o abbastanza discriminate; il 91,1% ha la stessa percezione in relazione alle persone trans e non binarie.
È doverosa in chiusura una nota metodologica. Il campione è parziale e – per ammissione stessa del documento – scarsamente rappresentativo: sono state, infatti, consultate le oltre 21mila persone residenti in Italia che al primo gennaio 2020 risultavano in un unione civile o unite civilmente in passato, sia in Italia che all’estero. Si tratta, quindi, di un campione ridotto di una popolazione più ampia, composto da persone che hanno scelto – per motivazioni varie che vengono analizzate nel rapporto, in primis il riconoscimento di diritti altrimenti negati – un riconoscimento legale del proprio rapporto di coppia. Un’ulteriore considerazione riguarda la denominazione della ricerca. L’acronimo Lgbt+ usato nel titolo suggerisce che la rilevazione riguardi la relazione tra condizioni ed esperienze di lavoro, da un lato, e orientamento sessuale e identità di genere dall’altro: in realtà, i dati riportati fanno esclusivo riferimento all’orientamento sessuale. Inoltre, la tabella che riporta le caratteristiche socio-demografiche del campione (pagina 2) non include – accanto ad altre variabili di rilievo, quali età, cittadinanza e titolo di studio – l’identità di genere di chi ha risposto. Sarebbe stato, dunque, più corretto rimarcare che la ricerca si focalizza su un campione Lgb: cosa, tra l’altro, che non desterebbe stupore data l’assordante mancanza di dati sulla popolazione trans e non binaria residente in Italia.
Il rapporto si chiude con una sezione di estremo interesse relativa alle azioni e alle politiche che il campione ritiene auspicabili per contrastare le discriminazioni e favorire l’inclusione della popolazione Lgb nel mercato del lavoro. La maggioranza delle persone (71,7%) evidenzia la necessità urgente di attività di formazione, sensibilizzazione o campagne sulle diversità Lgbt+ da parte delle istituzioni pubbliche. Possibili misure legislative statali o comunitarie, così come politiche sindacali e degli organismi di parità e diversity, vengono sì citate ma con un notevole distacco rispetto al sopra menzionato cambiamento culturale.
L’affossamento del cosiddetto “Ddl Zan” lo scorso anno ha lasciato il segno nella percezione del campione: l’89,1% del campione si è dichiarato favorevole a una legge contro l’omo-lesbo-bi-transfobia. Infine, nel questionario era possibile indicare liberamente ulteriori misure auspicabili per l’inclusione. La maggior parte delle persone ha espresso l’urgenza di interventi educativi e di formazione sulle questioni Lgbt+ nelle scuole, assieme a un maggiore riconoscimento delle genitorialità non eterosessuali, a strumenti di tutela per la popolazione Lgbt+ anziana e alla possibilità di un accesso più agevole ai percorsi di affermazione di genere per le persone trans e non binarie.
Alla luce di questi dati, è chiaro che la strada per garantire l’inclusione delle persone Lgbt+ nel mondo del lavoro così come nella società, e per contrastare – soprattutto a livello culturale – le discriminazioni e lo stigma, è ancora lunga. Prima dell’elaborazione di politiche efficaci, tuttavia, è cruciale proseguire e rafforzare le attività di raccolta dati su questa parte della popolazione, soprattutto per quanto riguarda i sotto-gruppi dell’acronimo che ancora faticano a ottenere la visibilità necessaria, come la popolazione trans e intersex. E per farlo c’è bisogno di volontà politica e di fondi sufficienti. Il rapporto di Istat e Unar è un buon passo in questo senso ma c’è ancora molto da fare.
Nota
[1] Il totale di queste percentuali è pari al 95,2% del campione considerato. Per il restante 4,8%, lo 0,2% dichiara un orientamento asessuale, l’1,3% un altro orientamento, la quota restante preferisce non rispondere.
Leggi anche