Il rapporto LOST fa il punto sulla dispersione scolastica, che riguarda quasi un terzo dei giovani italiani, soprattutto maschi. Quali sono le azioni di contrasto, con quali risultati e a fronte di quale spesa? Un primo dato: a investire di più è il terzo settore
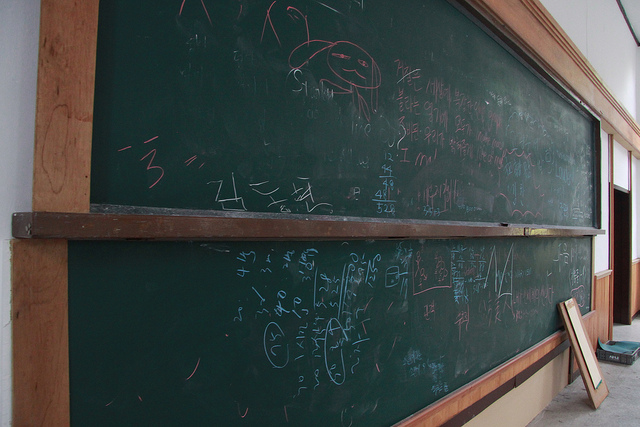
Eurostat colloca l’Italia in fondo alla classifica europea, con il 17% dei giovani tra i 18 e i 24 anni che ha solo la licenza media nel 2013. Una stima messa in discussione da altri rapporti, che elevano la percentuale di almeno 10 punti. I dati sull’abbandono precoce dei percorsi educativi nel nostro paese sono da tempo considerati allarmanti, sia all’interno del dibattito nazionale che europeo. Sebbene le misure di contrasto promosse finora abbiano determinato un apprezzabile calo nell’ultimo decennio, ancora quasi un terzo dei giovani abbandona gli studi prima del diploma, oppure frequenta attività formative che non permettono l’accesso all’università. Intanto, gli obiettivi europei per il 2020 parlano di una riduzione della fascia di popolazione che ha soltanto la licenza media, e auspicano un aumento dei giovani con diploma superiore e con laurea.
Un secondo elemento preoccupante è rappresentato dalle basse performance degli studenti che non abbandonano gli studi, ma ricavano dalla frequenza scolastica solo conoscenze, capacità e competenze assolutamente inadeguate per la loro vita quotidiana di cittadini e per il loro inserimento nel lavoro. Questa dispersione “nascosta”, che ha dimensioni significative, non è meno insidiosa del fenomeno dell’abbandono precoce degli studi.
La dimensione quantitativa del fenomeno della dispersione scolastica richiede attenzione e in questo senso il rapporto finale della ricerca LOST [1], diffusa a ottobre 2014, presenta un’efficace elaborazione delle informazioni attualmente disponibili sia a livello nazionale, che a livello regionale, con riferimento ai territori provinciali.
Ad abbandonare sono i maschi
Ad abbandonare con maggiore frequenza sono i maschi e gli istituti al primo posto per numero di abbandoni sono i professionali, specie quelli con maggiore presenza di maschi, seguiti da quelli tecnici. Le regioni meridionali, con speciale riferimento alle maggiori aree metropolitane, spiccano per la loro forte problematicità, anche per gli abbandoni della scuola media.
La prevalenza di giovani uomini tra coloro che abbandonano precocemente l’istruzione propone una speciale questione di genere che andrebbe meglio indagata.
Considerando le performance scolastiche, misurate dai risultati dei test sugli apprendimenti, emergono dati non univoci. Nel 2012 i test PISA rilevano che le ragazze di 15 anni sono mediamente più brave dei maschi coetanei nelle prove di italiano (differenza statisticamente significativa di 39 punti), meno brave dei maschi nelle prove di matematica (differenza statisticamente significativa di 18 punti) e non emergono differenze significative nelle prove di scienze. Altri elementi, che andrebbero valutati e ponderati, sono le differenze di genere nei comportamenti che hanno rilevanza disciplinare, nella capacità di sopportazione della noia e della fatica che potrebbero essere fortemente condizionata dai modelli culturali di genere e, infine, nelle aspettative delle famiglie nei confronti del conseguimento di un diploma. In alcuni territori, specie negli anni che hanno preceduto la profonda crisi attuale, e con riferimento specifico alle aree dove prevalgono le imprese industriali di piccola e media dimensione, le tensioni dal lato della domanda di lavoro possono avere “tirato” fuori dalle scuole giovani, poco o per nulla qualificati, che si sono inseriti nei posti di lavoro manuale delle imprese meno dinamiche e alla ricerca di lavoratori da pagare poco. Questa pressione del mercato del lavoro può essersi concentrata sui giovani maschi più che sulle giovani donne.
Eppure, il costo della scarsa scolarizzazione per gli individui è rilevante e stimabile tra l’1% e il 5% di perdita di reddito mediamente fruibile nell’arco della vita. L’azzeramento dell’abbandono precoce degli studi potrebbe aumentare il prodotto interno lordo da un minimo dell’1,45% fino ad un massimo del 6,8%, dimostrando il peso complessivo del pessimo funzionamento del sistema educativo nazionale.
Quando e perché si verifica l'abbandono
La concentrazione dell’abbandono degli studi alla fine del primo biennio della scuola superiore sembra indicare che le norme sull’obbligo di istruzione fino a 16 anni e al compimento di 10 anni di scolarizzazione riescono a contenere l’abbandono. Allo stesso tempo, le norme sull’obbligo formativo, ovvero sull’obbligo di conseguire una qualifica o un diploma entro il diciottesimo anno, appaiono molto meno incisive.
L’analisi qualitativa delle cause del fenomeno degli abbandoni e delle scarse performance scolastiche trova d’accordo la maggior parte degli studiosi. Gli insuccessi, specie le ripetenze plurime, insieme al disagio sofferto per un clima educativo-relazionale non favorevole sono due importanti elementi associati alla conclusione precoce dell’esperienza educativa. Altri fattori influiscono negativamente sulla motivazione e sono più difficili da individuare, essendo connessi con un complesso di influenze famigliari, culturali e di contesto che possono sostenere la fatica degli apprendimenti e i progetti per il futuro, oppure ostacolare la partecipazione efficace al sistema educativo. La condizione sociale ed economica della famiglia di origine e del contesto ambientale di riferimento influiscono grandemente, attraverso la motivazione, sia sulla probabilità di completare gli studi che sul livello delle performance e la qualità degli apprendimenti. Ci sono elementi di disagio personale, le difficoltà specifiche di apprendimento e le condizioni di disabilità che influiscono in maniera rilevante, nonostante le azioni di integrazione e sostegno previste in tutte le scuole. Infine, sulle traiettorie educative dei giovani influisce anche l’origine etnica e culturale, attraverso molteplici canali, compreso il sovrapporsi di condizioni economiche di povertà e l’isolamento sociale.
Contrasto alla dispersione, è il terzo settore a investire di più
I finanziamenti pubblici sono la condizione per l’avvio del 35% delle iniziative realizzate dalle scuole e sostengono circa il 25% del totale delle risorse che impiegano gli enti del terzo settore che operano per il contrasto dell’abbandono scolastico.
La rilevanza delle azioni promosse dal terzo settore, con o senza patti di collaborazione con le scuole, è evidente se si considera il valore economico degli interventi. Il terzo settore da solo, secondo le stime della ricerca LOST, investe ogni anno 60 milioni di euro e il Ministero dell’Istruzione investe circa 55 milioni di euro in progetti attivati nelle scuole, principalmente con finalità di recupero delle carenze di apprendimento. Infine, la ricerca LOST valuta che l’intervento del privato sociale produce effetti moltiplicatori delle risorse, data la forte presenza di lavoro volontario, pari in media ad 1 euro e 60 centesimi per ogni euro speso.
Le differenze territoriali sono molto significative e non sono legate solo alla disponibilità dei fondi strutturali europei, finora riservati ad alcune regioni del sud. Il ruolo degli enti locali nel finanziare le azioni delle scuole per il contrasto della dispersione è condizionato dalle regole che ogni regione si è data autonomamente e mette in campo sia le risorse per l’istruzione che quelle destinate ai servizi sociali. La capacità che alcuni enti locali hanno in maniera più spiccata di intercettare i bisogni delle scuole e di costruire strutture di consulenza e supporto alla progettazione educativa emerge come fattore rilevante nell’analisi del funzionamento dei differenti territori.
Quali misure di contrasto
Ben il 60% delle attività di contrasto realizzate dalle scuole sono concentrate ad aumentare il rendimento scolastico e il 47% delle azioni realizzate dagli enti del terzo settore offrono aiuto nei compiti scolastici. Gli interventi di contrasto, quindi, affrontano principalmente l’insuccesso scolastico, che è forse la più rilevante tra le cause dell’abbandono scolastico, ma non certo l’unica.
Le azioni delle scuole per migliorare il clima relazionale in classe sono poco meno della metà (il 47%) del totale delle loro azioni di contrasto. Quelle analoghe, realizzate dal terzo settore, costituiscono il 26% delle azioni totali realizzate dagli enti. Si tratta di attività di tipo ludico o laboratoriale, quasi sempre non curricolari, per favorire l’aggregazione dei giovani e la loro socializzazione, quindi con l’intento di incidere sulla motivazione allo studio e sul benessere complessivo. Questo genere di attività richiede competenze differenti da quelle didattiche disciplinari, che sono prevalenti all’interno delle scuole, e pertanto ci si potrebbe aspettare una specializzazione degli enti del terzo settore. Al contrario, e sorprendentemente, questa tipologia di azioni non è prevalente tra quelle proposte dagli enti.
Oltre ai contenuti, per provare a descrivere la qualità delle azioni realizzate, occorre considerare le metodologie con cui si realizzano gli interventi e la capacità di coinvolgimento delle fasce più a rischio della popolazione scolastica. Ci si aspetta che le azioni di contrasto siano organizzate in modo differente dall’ordinaria attività di insegnamento, dato che tra le cause dell’abbandono si trova anche la rigidità con cui si organizzano le situazioni di apprendimento. La ricerca LOST mostra che solo il 40% delle azioni di contrasto dell’abbandono e dello scarso rendimento scolastico coinvolge gli studenti in piccoli gruppi o singolarmente, per affrontare le specifiche difficoltà, personalizzando gli interventi di sostegno. Il 53% delle azioni è di tipo generalista e non è necessariamente focalizzato sulla prevenzione o il contrasto dell’abbandono. Infine, l’8% delle azioni coinvolge grandi numeri di studenti e dura anche più anni, spesso con obiettivi educativi e culturali generali.
Per quanto riguarda la capacità di individuare la popolazione target più a rischio di abbandono, colpisce che gli studenti stranieri siano scarsamente coinvolti, nonostante abbiano maggiori difficoltà e abbandonino più frequentemente gli studi prima di conseguire il diploma.
Nel complesso, emerge una situazione con molte ombre con una grande necessità di una qualificazione.
Le competenze che le scuole non hanno
Le scuole possono trarre grande giovamento dalla collaborazione con altre istituzioni e con enti del terzo settore, specie se questi dispongono di competenze che nella scuola non ci sono o sono sottodimensionate. Potrebbero essere utili competenze di tipo psicologico, sociologico, medico, antropologico e più in generale quelle capacità progettuali, di monitoraggio e di valutazione che sono necessarie per sorreggere una sperimentazione ad ampio spettro.
Ciò che emerge, invece, è un quadro diverso. Il 50% dei programmi delle scuole per contrastare la dispersione è realizzato in totale autonomia, quindi si basa innanzitutto sulle competenze e le risorse finanziarie interne. Ci sono programmi relativamente ricchi di risorse, che coinvolgono molti docenti, profittano di consulenti esterni e ricevono finanziamenti aggiuntivi, ma ciò nonostante hanno un carattere generalista e non sono focalizzati nel contrasto dell’abbandono o nel miglioramento del rendimento scolastico. Sembra che, le collaborazioni esterne, attivate dalle scuole per avere più competenze o più mezzi finanziari, non impediscano la realizzazione di azioni poco mirate e forse poco efficaci. Infine, colpisce che gli enti del terzo settore siano coinvolti troppo spesso in azioni che mettono in campo competenze “concorrenti” con quelle delle scuole.
Differenze territoriali
La ricerca LOST si concentra sulle azioni di contrasto che le scuole e le organizzazioni del terzo settore realizzano nei quattro territori metropolitani più popolosi del nostro paese: Milano, Roma, Napoli e Palermo.
A Milano e Palermo si rileva una maggiore presenza di scuole che non hanno attivato progetti di contrasto al basso rendimento e all’abbandono scolastico. Viceversa a Napoli c’è la percentuale più elevata di scuole che ha messo nel Piano dell’Offerta Formativa almeno uno di questi interventi. I ricercatori LOST suggeriscono che, anche se in modo non molto marcato, le iniziative del sistema scolastico per contrastare la dispersione sembrano crescere al crescere dell’incidenza del fenomeno dell’abbandono. Al contrario, il terzo settore sembra intervenire in modo slegato dall’effettivo fabbisogno in questo campo, che per numerosi enti rappresenta uno solo degli ambiti della loro azione nel territorio in cui operano.
Mentre a Palermo e Roma le scuole e il terzo settore agiscono in modo complementare, a Milano e Napoli sembra emergere un quadro di azioni indipendenti e poco coordinato. A Roma sembra emergere una qualche divisione dei compiti tra scuole e terzo settore. A Palermo, addirittura, sembra prevalere un rapporto di “sostituzione” tra scuole e terzo settore: dove le scuole mettono in campo interventi sostanziali, il terzo settore si defila. Viceversa, dove le scuole non promuovono progetti contro la dispersione e il basso rendimento, il terzo settore si fa avanti e compensa con proprie iniziative la mancanza del settore pubblico. Al contrario, a Milano, il terzo settore si comporta come un’alternativa alla scuola, con cui non cerca relazioni molto strette e mette in campo azioni rivolte agli individui che vivono situazioni problematiche causate dalla scuola.
Queste differenziazioni territoriali potrebbero riflettere sottostanti modelli organizzativi e di interazione tra il settore pubblico e il terzo settore. Potrebbero anche essere il frutto di peculiari assetti istituzionali dei territori, specie con riferimento ai contenuti dei bandi che le amministrazioni locali emettono per erogare finanziamenti pubblici. Le regole per l’accesso ai bandi possono favorire le collaborazioni, oppure possono spingere il terzo settore ad operare senza convenzioni e collaborazioni con il settore pubblico. In generale, i ricercatori LOST propendono per descrivere gli interventi delle scuole e del terzo settore come rispondenti a logiche diverse che si attivano nel territorio con interventi troppo spesso slegati tra di loro. Non c’è né vera complementarietà né assoluta sussidiarietà, ma ci sono elementi dell’una e dell’altra situazione. Sembra emergere con evidenza un’assenza sistematica di comunicazione e coordinamento tra scuole ed enti. Le collaborazioni, anche quando sono formalizzate da protocolli d’intesa, in realtà appaiono come adempimenti formali che non promuovono una reale collaborazione. D’altra parte, la costruzione di partnership territoriali tra le scuole e gli enti del terzo settore non garantisce di per sé una progettazione adeguata e una capacità di realizzazione efficiente.
In conclusione, dalla ricerca LOST emerge che anche quando esistono forme più o meno efficaci di collaborazione tra scuole, terzo settore ed enti locali, molti operatori intervistati percepiscono un vuoto istituzionale, la mancanza di un forte presidio che favorisca sia le collaborazioni che le realizzazioni di azioni efficaci. Infine, il fatto che le azioni di contrasto siano vissute con grande disillusione da molti docenti, che sembrano arrendersi di fronte a difficoltà di ogni tipo e alla riduzione evidente delle risorse disponibili, non favorisce certamente l’innovazione e la realizzazione di azioni efficaci. Il ritirarsi dietro il rispetto formale dei doveri ministeriali, da parte della quota più attiva degli insegnanti, è tra gli elementi più dannosi per il miglioramento della situazione.
NOTE
[1] L’indagine LOST, con il patrocinio dell'Autorità Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, è stata promossa da WeWorldIntervita, dall’Associazione Bruno Trentin e dalla Fondazione Giovanni Agnelli.









