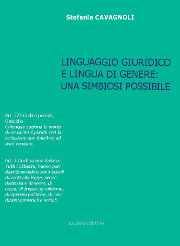Stefania Cavagnoli, professoressa associata di linguistica e glottologia, affronta il tema sviluppandolo attorno al potere evocativo della lingua di immagini, situazioni e, inevitabilmente, ruoli
Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile
L’idea originaria era quella di aprire le danze sul testo pluri-anime di Stefania Cavagnoli, al contempo attualissimo e squisitamente accademico, con una introduzione al problema: curioso come il tema dell’utilizzo di un linguaggio giuridico adeguato e rispettoso dei crismi della lingua di genere si sia, a tutti gli effetti, affermato in Italia come un nodo problematico.
A parlare è, in tutta sincerità, un’ex scettica riguardo la possibilità di riconoscere alla questione dell’utilizzo di una grammatica e di una lingua di genere la dignità di problema sostanziale: per lungo tempo ho io stessa preferito guardare al nostro ruolo nella società e nelle dimensioni professionali, storicamente appannaggio dell’universo maschile, prescindendo dall’importanza dell’utilizzo di un linguaggio adeguato alle istanze provenienti dalla cultura di genere e, quindi, sottovalutandone la potenza.
L’incontro con questo testo - e con gli strumenti che l’autrice mette a disposizione - è stato, perciò, ancor più significativo, poiché ad esso si è associato un principio di cambiamento di rotta di chi fino a poco fa tendeva ad affrontare la questione più come un 'vezzo' socio-culturale che come un passaggio fondamentale.
Stefania Cavagnoli, professoressa associata di linguistica e glottologia, affronta il tema sviluppandolo attorno al potere evocativo della lingua di immagini, situazioni e, inevitabilmente, ruoli: è questo il punto di partenza di un’ analisi puntuale volta a dimostrare la non marginalità dell’utilizzo della lingua di genere nelle discipline e nelle relazioni sociali tipiche della dimensione giuridica.
La struttura che caratterizza questo lavoro lo rende, ancor di più, strumento fruibile per chi - come la sottoscritta al momento della prima lettura - non possiede adeguate conoscenze linguistiche e sociologiche in materia: i primi tre capitoli sono dedicati all’inquadramento del tema della lingua di genere e alla sua definizione, attraverso la 'lente' dell’approccio italiano rispettivamente in campo linguistico, giornalistico e normativo.
Il capitolo quarto, di significativo interesse e grande attualità per le giuriste ed i giuristi, entra nel vivo della tematica contestualizzandola nei differenti scenari che appartengono al mondo del diritto. L’autrice mostra, in questa parte della monografia più che mai, non soltanto la sua dimestichezza con il linguaggio giuridico, di cui ha acquisito un’adeguata conoscenza, bensì anche la sua confidenza con la dimensione delle professioni legali e con il ruolo che nella storia è stato ivi riconosciuto alla donna giurista.
Disseminati nel testo si trovano continui riferimenti a utilissimi strumenti di informazione, anche più o meno divulgativi, in merito al problema dell’utilizzo di un linguaggio giuridico gender- friendly, ma non si trascura, altresì, l’evoluzione che ha interessato, nel tempo, il ruolo della donna giurista. In particolare, nel capitolo citato da ultimo, si riportano passaggi fondamentali degli episodi connessi al primo timido (ma non troppo) bussare delle giuriste alla porta della magistratura, dell’avvocatura e delle professioni legali in genere e, di conseguenza, della risposta che ad esse fu data dalle rispettive categorie di (non)appartenenza.
Si prosegue, poi, calando nella dimensione applicativa le teorie linguistiche fino a quel momento presentate e difese, attraverso un’analisi puntuale di testi giuridici presi a campione. Conclude il lavoro l’apertura di una finestra su esperienze linguistiche straniere ed istituzionali europee, che attribuisce all’opera un respiro comparativo ed un afflato internazionalista, conferendole un taglio ancor più attuale.
La velocità con cui la mia generazione ha il dovere di pretendere che questo mondo si muova deve rispecchiarsi nella presa di coraggio di una radicale riforma delle strutture linguistiche e culturali utilizzate in contesti ormai occupati in modo del tutto paritario da uomini e donne. Le questioni connesse al conio e all’utilizzo di un linguaggio giuridico di genere sono state affrontate principalmente dalla linguistica, prima ancora che dalla scienza giuridica, ed in ciò, onestamente, non trovo alcuna stranezza. Linguisti e linguiste ci forniscono strumenti tecnici e spunti di riflessione: ai giuristi e alle giuriste in egual misura si richiede quantomeno di prestare attenzione a una problematica che si dimostra tutt’altro che marginale e secondaria nella riscrittura del ruolo della donna giurista all’interno delle professioni o, quantomeno, di parlarne.
Significativa è stata la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense al venire alla luce del testo, tradottasi nelle due prefazioni, rispettivamente nella persona della Consigliera Avv. Susanna Pisano e del Presidente Prof. Avv. Guido Alpa, che hanno magistralmente recepito l’importanza del lavoro nell’ottica della costruzione di un’avvocatura del terzo millennio; lo stesso ha fatto la Scuola Superiore dell’ Avvocatura, nell’allestimento del laboratorio di scrittura, che vede la Prof. Cavagnoli alla guida del progetto.
Infine, la nuova legge professionale e il nuovo codice deontologico degli avvocati si sono inseriti a pieno titolo nel progetto di ristrutturazione della professione in chiave di pari opportunità: spetta adesso, quindi, alle utilizzatrici e agli utilizzatori 'finali' promuovere la cultura di genere, partendo in primis dall’attenzione ai profili linguistici ad essa connessi.
Il testo costituisce prova della interiorizzazione della problematica da parte di una “non addetta ai lavori del diritto” che si fa strumento fondamentale per gli addetti e le addette ai lavori, contro ogni scetticismo.
Spesso il diritto e il suo linguaggio hanno bisogno di tempo e non si muovono, di fatto, alla medesima velocità della dinamica sociale, ma, più facilmente, la seguono e vi si adeguano: due cari amici, Giulio e Giulia, rispettivamente ingegnere e psicologa, hanno nel tempo tentato di mostrarmi questa particolarità del diritto, forti del punto prospettico delle loro reciproche scienze. Mi auguro che la lettura di questo testo spinga chi come me ha faticato un po’ ad ammettere questa 'diversa velocità' ad adottare, invece, un punto di vista flessibile, eclettico ed in continuo cambiamento, ricercando nelle altre discipline, come, in questo caso, la linguistica, gli strumenti necessari all’evoluzione giuridica.
Stefania Cavagnoli, Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile, Edizioni dell'Orso, 2013