Non può più esistere un femminismo che non metta al centro una prospettiva intersezionale. Due letture per ripensare le pratiche e riformulare gli immaginari, a partire dai margini. Perché, finché una sola donna sarà oppressa, nessuna sarà davvero libera

Cosa lega una scrittrice e attivista femminista afroamericana di Chicago a un'economista ed esperta di studi di genere di Palermo? Da una parte Mikki Kendall, dall'altra Claudia Fauzia; nel mezzo, la lotta contro un femminismo elitario e autocelebrativo e il riconoscimento delle battaglie portate avanti dalle donne ai margini, invisibili ma insostituibili.
Kendall denuncia come, per troppo tempo, le donne afroamericane siano state escluse dal discorso femminista dominante.
Fauzia ci parla invece di un femminismo che combatte il patriarcato intrecciato con l’antimeridionalismo. Due forme di oppressione che non si sommano soltanto, ma si amplificano a vicenda, come in una tempesta perfetta. Nel nostro paese, i divari geografici tra Nord e Sud, tra città e campagne, non sono neutrali: creano gerarchie. Diritti, opportunità di formazione, opportunità di lavoro, accesso alla sanità – tutto è distribuito in modo diseguale. Fauzia denuncia un sistema che abbandona le donne del Sud, relegandole a una cittadinanza ‘di serie B’.
Il loro lavoro assume un’importanza straordinaria all'interno della più ampia cornice dell’intersezionalità, e ci ricorda che l’oppressione non è mai unidimensionale, essendo plasmata dalla razza, dalla classe, dal genere e da tanti altri fattori che si intersecano fra loro. Il femminismo delle donne bianche spesso ha trascurato proprio queste intersezioni, rimanendo complice, in maniera più o meno consapevole, di un sistema basato sulla supremazia di razza e sul capitalismo.
Le donne nere, latine, asiatiche, medio orientali, le donne queer e quelle delle classi sociali più svantaggiate erano invisibili, le loro esperienze marginalizzate. Non è più così: riconoscendo che nessuna lotta può dirsi completa finché tutte le donne, indipendentemente da chi siano o da dove provengano, non saranno libere, il femminismo intersezionale contemporaneo non è solo un’evoluzione, ma una rivoluzione.
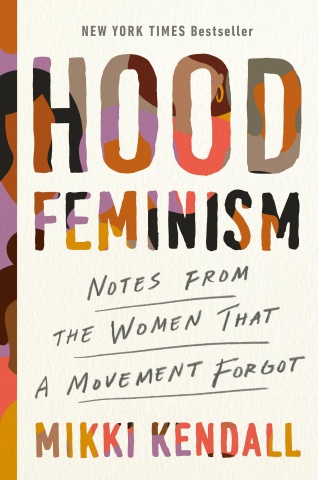
Per chi conosce il lavoro di Kendall come figura di riferimento nel pensiero femminista nero, non sarà una sorpresa scoprire che il suo saggio Hood Feminism: Notes from the Women White Feminists Forgot (Penguin Random House, 2020) si fonda proprio su questa prospettiva.[1]
Il termine intersezionalità fu coniato da Kimberlé Williams Crenshaw, giurista e attivista statunitense e professoressa alla Columbia Law School, per descrivere l'intreccio fra razza e genere, e come questo abbia ripercussioni, in particolare, sulle donne nere all’interno del sistema di giustizia penale.
Con una prosa chiara, incisiva e tagliente, nel suo libro Kendall svela come il femminismo abbia mancato di tener conto delle popolazioni troppo spesso escluse dal suo vessillo, trascurando l'ampiezza delle questioni che influenzano la vita quotidiana di milioni di donne afroamericane.
Molte parti del libro della studiosa si concentrano su come le armi, la fame, la povertà, l'istruzione, l'alloggio, la giustizia riproduttiva con cui le donne afroamericane devono fare i conti siano tutte questioni femministe. I capitoli Black Girls Don't Have Eating Disorders (le ragazze nere non soffrono di disturbi alimentari) e The Hood Doesn't Hate Smart People (la periferia non odia le persone intelligenti), sfidano miti dannosi che, nel primo caso, possono impedire a giovani donne di ricevere l’aiuto e il supporto di cui hanno bisogno e, nel secondo, perpetuano stereotipi basati su razza e classe sociale.
Indipendentemente dall’argomento, ogni capitolo è pensato per “concentrarsi in gran parte sulle esperienze delle persone emarginate e affrontare le questioni che riguardano la maggior parte delle donne, invece di quelle che interessano solo poche – come è stata finora la pratica comune del femminismo – perché affrontare questi problemi più ampi è fondamentale per raggiungere l’uguaglianza per tutte le donne” scrive Kendall.
Per garantire questa uguaglianza, l'autrice sostiene che le donne bianche devono accettare alcune verità scomode, in particolare “la concreta possibilità che alcune donne stiano opprimendo altre donne. Le donne bianche possono opprimere le donne di colore, le donne eterosessuali possono opprimere le donne lesbiche, le donne cisgender possono opprimere le donne trans, e così via”.
Se il femminismo vuole davvero rappresentare tutte le donne, allora, deve resistere alla “tendenza a dare per scontato che tutte le donne stiano vivendo le stesse lotte, che ci ha portato a un punto in cui le immagini legate alla salute riproduttiva si concentrano su donne cisgender abili, escludendo chi è trans, intersex o vive in corpi che non si adattano all'idea ristretta che i genitali definiscano il genere”.
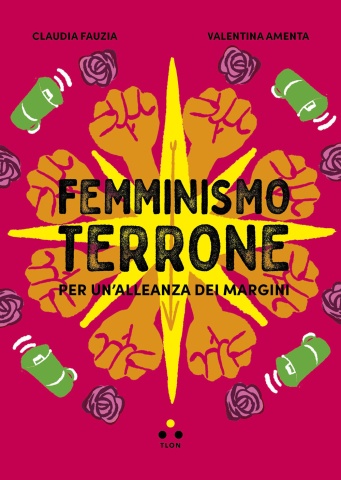
Dall’altro lato dell’oceano, Femminismo Terrone. Per un’allenza dei margini (Edizioni Tlon, 2024), scritto da Claudia Fauzia e Valentina Amenta, dottoressa di ricerca in studi di genere all'Università Sapienza di Roma, si riappropria della parola ‘terrona’, trasformandola in un simbolo di forza e resistenza. Questa operazione parte dal desiderio di scardinare il vittimismo che può colpire le donne del Sud, poiché l’antimeridionalismo non si limita a strutture esterne, ma penetra anche nella dimensione più intima e privata della percezione di sé, diventando una parte integrante del modo in cui, in quanto donne meridionali, vediamo e definiamo noi stesse.
È anche un atto d’accusa al movimento femminista italiano per aver trascurato, almeno in parte, le sorelle del Sud. Le condizioni di vita delle donne meridionali sono state spesso ignorate, relegate in secondo piano o considerate trascurabili, forse perché il movimento ha dato priorità ad altre questioni. Femminismo terrone invita a pensarsi a partire dal Sud, da ciò che è o non è, e non sempre e solo in relazione al Nord. Questa riflessione riguarda un modello di sviluppo per il Sud che è stato deciso arbitrariamente da altri. Amenta e Fauzia sottolineano come il movimento critichi l'idea che lo sviluppo del Sud debba necessariamente essere una rincorsa, un futuro sempre incompiuto, perché deve coincidere con quello del Nord.
C’è però un presupposto che Fauzia e Amenta, nella prospettiva femminista meridionale, tengono in considerazione rispetto alla "questione meridionale": non si tratta solo di analizzare le discriminazioni sistematiche antimeridionaliste e cambiare l’immaginario di inciviltà associato al Meridione, ma di collocare questi fenomeni in un contesto più ampio. Occorre superare la semplice dicotomia Nord-Sud d’Italia e considerare l’intersezione con categorie come genere, razza, orientamento sessuale e abilità, che risultano determinanti. Inoltre, la questione meridionale si basa spesso sull’idea che questa contrapposizione sia unicamente interna al paese, trascurando il rapporto con il resto del mondo, dove si articolano disuguaglianze sistematiche – come il ruolo dell’Italia nel colonialismo, i movimenti migratori e le connessioni tra l’archivio discorsivo coloniale e la tradizione antimeridionalista.
In questo senso, la tesi di un "femminismo terrone" si avvicina molto a quella dell’hood feminism di Kendall: entrambe contestano il “capitalismo globale come sistema unificato, basato sulla divisione globale del lavoro, e su relazioni di sfruttamento tra centro, periferia e semiperiferia del mondo. Dove le gerarchie economiche e culturali generate all’interno di questo sistema intrinsecamente colonialista, si protraggono fino a oggi e prendono il nome di colonialità”.
Decolonizzare il femminismo significa riconoscere che concetti come progresso, civiltà e sviluppo, pur rappresentando una fase specifica nell’evoluzione della storia europea, non possono essere imposti come parametri universali per giudicare le esperienze e i modi di vita di altri contesti. Il sistema coloniale europeo, nella sua attuale declinazione di capitalismo neoliberista, si presenta come simbolo di civiltà e si legittima nello sfruttamento di terre e persone, rafforzando l’idea che la subordinazione di alcune soggettività sia necessaria per il funzionamento del sistema.
Queste voci ci ricordano che la nostra liberazione è intrecciata a quella di tutte le altre. Il femminismo deve saper smantellare non solo il patriarcato, ma ogni forma di oppressione. Finché una sola donna sarà oppressa, nessuna sarà davvero libera. Riflettere sul femminismo partendo dai margini potrebbe gettare le basi per una nuova prospettiva del movimento, più inclusiva e meno legata a logiche classiste.
Note
[1] In slang americano, il termine ‘hood’ è un'abbreviazione di neighborhood (quartiere), e viene utilizzato per indicare un quartiere, spesso riferito a contesti urbani abitati prevalentemente da persone afroamericane e caratterizzati da un basso livello socioeconomico.












