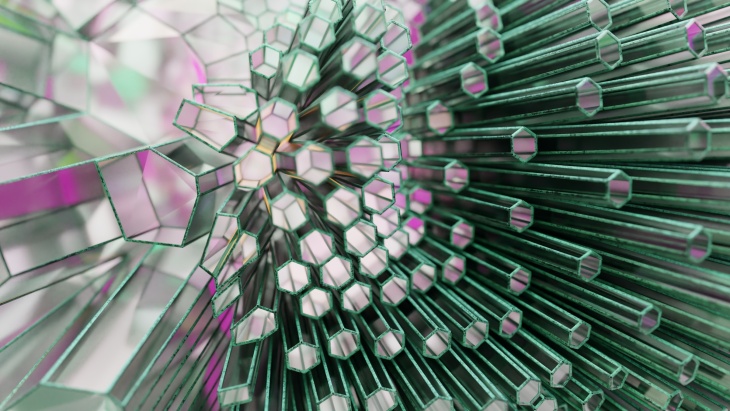Sei storie, sei modi diversi di interrogarci sulla salute mentale. Nel suo saggio, Stranieri a noi stessi, la scrittrice e giornalista americana Rachel Aviv ricostruisce attraverso un'indagine sui vissuti individuali la storia più recente della psichiatria, sviscerando i nessi tra depressione e oppressione

Qual è il confine tra depressione e oppressione? Nel suo saggio Strangers to ourselves, pubblicato negli Stati Uniti nel 2022, e da poco uscito in Italia per Iperborea con il titolo Stranieri a noi stessi, la scrittrice e giornalista americana Rachel Aviv ci consegna una raccolta di storie che forse è prima di tutto un tentativo di indagare questo nodo rimasto sommerso nei nostri discorsi.
Oggi sempre più spesso si sente parlare di “salute mentale” ma nessuno si chiede cosa vuol dire essere malati di mente. Tra le pagine di questo libro, Rachel Aviv sembra avvertirci: se non mettiamo a fuoco i sentimenti che ci legano all’idea che abbiamo di “malattia” continueremo a girare intorno alla “salute” trasformandola in una parola vuota che finirà per non significare più niente.
Le storie raccolte da Aviv sono, ognuna a suo modo, la manifestazione del fatto che a non funzionare più è la stessa contrapposizione tra questi due concetti. L’idea della malattia come un destino da cui emanciparsi attraverso una serie di espedienti, che riguardano esclusivamente le persone considerate come individui – e che di volta in volta verranno definite curabili o non curabili, funzionanti o non funzionanti, in altre parole più o meno aggiustabili.
Alle prese con le diagnosi elaborate da una psichiatria al collasso, ognuna delle persone protagoniste delle storie raccontate in queste pagine si trova invece continuamente schiacciata da una forza più grande, che ne limita o ne minaccia in qualche modo la libertà di esistere – intesa come la possibilità per un individuo di intraprendere quello che potremmo chiamare il “proprio corso” o la “propria forma”, qualsiasi cosa voglia dire.
Questa forza che è più estesa di un sé, più larga di una vicenda individuale, e che spesso viene tagliata fuori da narrazioni in prima persona singolare, la maggior parte delle volte è interpretata come una sorta di calamità, una contingenza dettata dal caso, un incidente. Il fatto che invece abbia sempre in qualche modo a che fare con “gli altri”, con una dimensione collettiva, con un orizzonte di senso condiviso, viene del tutto omesso dal discorso, quindi dalla comprensione delle cose.
Che ruolo hanno le storie che ci raccontiamo in tutto questo? si chiede e ci costringe a chiederci Aviv – testimonianze, pubblicità, racconti privati, ma anche cartelle cliniche, analisi, diagnosi. “La cultura modella i copioni che seguiremo per esprimere la nostra angoscia” scrive Aviv. “Le malattie mentali spesso vengono viste come forze intrattabili e incontrollabili che prendono possesso delle nostre vite, ma mi chiedo quanto le storie che raccontiamo su di loro, soprattutto all’inizio, possono modellarne il corso. Le persone possono sentirsi liberate da queste storie, ma anche rimanervi intrappolate”.

Aviv parte lucidamente da sé, dalla Rachel bambina che precocemente si ritrova in una clinica di cura per un’anoressia nervosa nell’America di fine anni 80 insieme a un gruppo di adolescenti. Dalla ragazza di nome Hava, sua compagna di stanza, che a un certo punto avrebbe desiderato diventare, perché ai suoi occhi era “qualcuno migliore di me”. E ci introduce progressivamente alle vite di Ray, un “uomo irrisolto” del Maryland che voleva fare il musicista e invece ha studiato medicina restando incastrato in una versione idealizzata di ciò che avrebbe potuto essere; di Bapu, una sposa zoppa del Chennai, nell’India del Sud, soffocata dal ruolo di moglie e madre impostole dalla famiglia, che trova rifugio nel misticismo e nella scrittura; di Naomi, “bellissima ragazza” nera del Minnesota “scollegata dalla realtà” che esasperata da una vita di stenti e discriminazioni si getta nel Mississippi con i suoi due figli gridando “libertà”; e infine di Laura, studentessa modello ad Harvard, convinta di “non avere un sé di base”, tenuta in scacco da un cocktail di psicofarmaci dentro la “vita di una sconosciuta”.
“Spesso l’anoressia è stata descritta come un disturbo di lettura determinato dal consumo acritico di testi che presentano la magrezza come ideale femminile” scrive Aviv raccontando la sua relazione con la compagna di stanza che fa da cornice al libro. “Avevo appena cominciato a imparare a leggere. Non avevo mai sentito parlare di anoressia. Quando mia madre mi riferì la diagnosi, la parola mi suonò come una tipologia di dinosauro”.
Ognuna delle persone raccontate da Aviv ha assunto psicofarmaci per un periodo o per la maggior parte degli anni della sua vita a seguito di una diagnosi di schizofrenia, disturbo bipolare, anoressia, psicosi, a seconda dei casi. Ognuna di loro è stata dichiarata pazza o fuori di testa dalla sua cerchia di parenti, colleghi, amici.
È interessante come nel ricostruirne i vissuti attraverso ricerche mediche e interviste a conoscenti e familiari, Aviv ripercorra in realtà soprattutto la storia recente della psichiatria occidentale – dall’assetto psicanalitico alla nascita del manuale DSM, fino agli approcci fondati sull’assunto che tutto dipenda da una matrice genetica e sia risolvibile o non risolvibile attraverso la farmacologia – quindi in quest’ultimo caso non risolvibile affatto. E che lo faccia rimettendo insieme i pezzi di un discorso intorno alla salute come un processo di “civilizzazione” quasi traumatico, in più di un senso colonizzatore.
In quest’ottica, le motivazioni di una “malattia mentale” sono da rintracciarsi praticamente sempre in un percorso obbligato. Solo talvolta, e parzialmente, in una serie di scelte fatte dalle singole persone. Quasi mai nei contesti sociali o nelle condizioni economiche, nell’appartenenza a un genere o a una razza, in un insieme di credenze tossiche o nocive ereditate, anche, al di fuori della famiglia di origine.
E se è vero che attribuire tutto a una matrice sociale può risultare generico, funzionare come una giustificazione per rendere un percorso intrasformabile a livello di “cure”, il problema principale di questo assetto consolidato è proprio che esclude del tutto le responsabilità condivise del malessere e della sofferenza a cui vanno incontro determinate persone più di altre.
La storia di Naomi, cresciuta negli anni Novanta nelle Robert Taylor Homes di Chicago, dove il 99 per cento degli abitanti era nero e il 96 disoccupato, ne rappresenta un valido esempio. “Quando vennero costruite nel 1962, le Homes” racconta Aviv “erano uno dei complessi di edilizia popolare più grandi del mondo. Ventotto palazzi di cemento identici, incastrati tra i binari del treno e una interstatale”. Ci abitavano 27.000 persone. “Naomi viveva al quindicesimo piano di un palazzo che faceva parte di quello che i residenti chiamavano il Buco” continua Aviv. Trovava la strada di casa “contando il numero di pianerottoli superati e spiando attraverso le porte per riconoscere il suo corridoio”.
Gli architetti bianchi come quelli che avevano ideato il comprensorio “non avevano i requisiti psicologici adatti per progettare case per la gente povera o di culture diverse” avrebbe decretato la rivista Black World qualche anno più tardi. Presto la vegetazione presente all’inizio sarebbe stata asfaltata per abbattere i costi di manutenzione, e in seguito, uno studio comparso su Environment and Behaviour, ci fa sapere Aviv, avrebbe scoperto che i residenti che in quel comprensorio avevano vissuto affacciati sul verde avevano avuto reazioni meno severe nell’affrontare le sfide di fronte a cui li aveva messi la vita.
“Le storie sulle malattie psichiatriche sono spesso profondamente individuali” scrive Aviv “la patologia emerge da dentro e così viene affrontata. Ma queste storie trascurano come e dove vivono le persone, i modi in cui la loro identità diventa un riflesso di come viene percepita dagli altri”.
La questione dell’identità è dirimente, se alle storie vogliamo prestare attenzione. Ancora poco si discute, per esempio, delle conseguenze che comporta nell’immaginario collettivo raccontare la sofferenza psichica come una malattia da cui si può guarire. Troppo spesso si parla di depressione come si parlerebbe di un’influenza – qualcosa che arriva a un certo punto della vita, che si può combattere e sconfiggere, che poi passa permettendo di tornare alla propria versione precedente.
“Per quelli di noi che lottano da anni, la storia della restituzione a se stessi non è reale” scrive in un saggio citato da Aviv la psicologa Pat Deegan a cui è stata diagnosticata la schizofrenia a diciassette anni, per criticare alcune campagne pubblicitarie sugli antidepressivi. “La nostra guarigione” scrive ancora “è contrassegnata da un’accettazione sempre più profonda dei nostri limiti”. Se esiste una possibilità, si tratta più che altro di un percorso di trasformazione. Quanto di più lontano da un “ripristino”.
È soprattutto questa recisione dalla realtà che rischia di rendere una bambina anoressica, una studentessa modello, una moglie impazzita, un uomo inadeguato, una cattiva madre, delle esistenze a parte, "straniere a se stesse” – come si definisce alla fine del libro la Hava adulta in una pagina di diario, e nonostante la conoscenza ormai approfondita del suo malessere, “non del tutto convinta di voler essere salvata”.
E come se in fondo la vita non fosse per definizione un incessante tentativo di reinterpretazione di sé, del proprio stare in relazione, una trasfigurazione progressiva; con tutto lo straniamento che questo necessariamente comporta, soprattutto se avviene al cospetto di un orizzonte che tende a colonizzare o sopprimere tutto quello che sfugge a un presunto e neutrale criterio di normalità.
Bisognerebbe allora cominciare a mettersi in ascolto delle cose, prima ancora di trovare le parole adeguate per descriverle, sembra suggerirci Aviv. Hava per esempio non parlava mai di “guarigione”, le racconta il compagno in un’intervista molti anni dopo che si erano perse di vista. “Non assegnava alla sua nuova condizione nessun termine specifico”. Diceva solo: “sono in un buon posto adesso”.