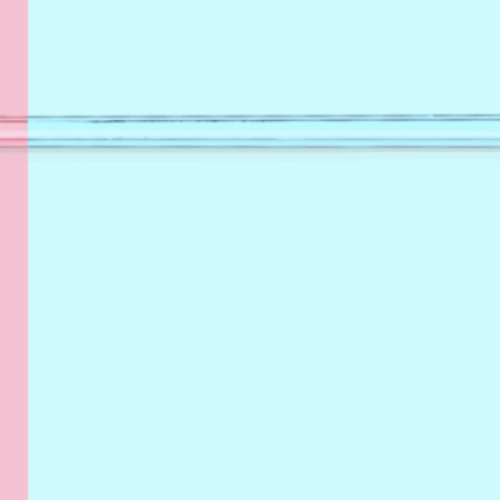Attacchi digitali e discorsi d'odio assediano sempre più spesso giornaliste e professioniste della comunicazione, a pieno titolo nel "girone" delle donne che prendono parola negli spazi pubblici invece di stare zitte. Una tendenza che fa il paio con alti livelli di disinformazione di genere e una bassa alfabetizzazione mediatica

Le donne che prendono parola nella sfera pubblica sono le principali destinatarie dei discorsi d’odio online, lo dimostra la mole sempre più vasta di rapporti dedicati al tema diffusi negli ultimi anni. Non risulta difficile, quindi, immaginare quanto questo fenomeno rappresenti un vero e proprio ostacolo per tutte quelle donne che nel mercato digitale lavorano come giornaliste e professioniste della comunicazione.
Certo non è un fenomeno che riguarda soltanto il digitale. Pressioni e molestie basate sul sesso sono state registrate anche nei tradizionali luoghi dell’informazione, dalla radio alla televisione alla carta stampata, ma la violenza di genere ha raggiunto livelli senza precedenti con la diffusione dei social media, e la pandemia da Covid19 ne ha costituito un potente detonatore.
È quello che si legge nelle indagini internazionali, lo speciale diffuso a marzo dall’International media support (Ims), organizzazione no profit che monitora la libertà di informazione nel mondo, ne raccoglie i principali risultati. Stando alle stime disponibili, sappiamo che il 73% delle giornaliste ha subito violenze online nel corso della carriera, che il 20% ha subito attacchi nel mondo fisico in qualche modo connessi a episodi di violenza digitale. E sappiamo che a causa della violenza online una giornalista su tre ha pensato di abbandonare la professione, in una cornice più ampia dove otto persone su dieci preferiscono autocensurarsi negli spazi digitali dopo aver subito attacchi.
Può trattarsi di enormi polveroni che sommergono la conversazione danneggiando la reputazione ed emarginando la persona in questione, oppure piccole gocce d’odio distillate nel corso di mesi o addirittura anni. Atti e pressioni che possono essere pubblici o privati, anonimi o da parte di colleghi, capi e familiari. Tutto questo ha conseguenze reali, non solo rispetto al pieno svolgimento della professione, e quindi dai molteplici risvolti economici, ma anche in termini di salute mentale e di sopravvivenza.
Il fenomeno è sicuramente trasversale, ma non svincolato dai contesti. La probabilità e l’intensità degli attacchi infatti aumenta in base al sesso e all’identità di genere, alla provenienza etnica e alla religione, alla classe sociale e ad altre caratteristiche che di volta in volta diventano significative.
“Le giornaliste nere, indigene, ebree, arabe e lesbiche subiscono i tassi più alti e gli impatti più gravi della violenza online” porta come esempio l'Ims. Il rischio cresce “quanto più donne, ragazze e persone non binarie sono attive nel dibattito pubblico”, e in base agli argomenti del discorso. Genere, diritti, violenza, aborto, politica, sono queste le aree più ad alto rischio.
Non è una coincidenza se, come riporta Unesco in un'istantanea sul tema, il 41 per cento delle giornaliste nel mondo è stata oggetto di campagne di disinformazione orchestrate: questo tipo di attacchi diventa infatti sempre più spesso parte integrante di vere e proprie manovre di istigazione all’odio da parte di gruppi di interesse che includono leader politici e soggetti attivi, a volte anche all’interno delle istituzioni.
“Mentre sia i giornalisti che le giornaliste sono esposti a violenze, minacce e ritorsioni connesse al loro lavoro, gli attacchi contro le giornaliste sono basati sul genere e altamente sessualizzati, online e offline”, ha affermato Irene Khan, special rapporteur delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e di espressione, che a novembre 2021 ha curato una raccolta di testimonianze in cui giornaliste di tutto il mondo raccontano uno spettro che dal trolling arriva fino allo stupro e alle minacce di morte, passando per violenze sessuali e molestie che si intensificano se le giornaliste in questione non sono bianche ed eterosessuali.
In Italia, dove esemplare è diventato il caso della giornalista Greta Beccaglia palpeggiata da un tifoso mentre un collega in studio la invitava a non prendersela, sappiamo dall’Osservatorio Vox, che da anni monitora l'andamento dei cattivi sentimenti digitali, di come le donne detengano il primato delle più odiate del web, soprattutto su Twitter (ora X), seguite da persone disabili e omosessuali. E del fatto che pandemia, guerre e crisi energetica abbiano creato l'humus ideale per l’inasprirsi dei discorsi d’odio, dopo il 2020 aumentati in modo esponenziale, anche quando rivolti a giornaliste e giornalisti – questi insieme, spiega la mappa più recente pubblicata dall’osservatorio a gennaio, raccolgono il 78,42 % di menzioni negative, una crescita significativa rispetto al 57% del precedente monitoraggio confrontabile, risalente al 2020.
La vicenda Beccaglia, commenta l'osservatorio “si è simbolicamente chiusa in primo grado con una condanna del tifoso a un anno e mezzo”, un risarcimento solo parziale se pensiamo che alla condanna giudiziaria di quell’atto inaccettabile di sessismo si è affiancata “l’amarezza espressa dalla giornalista per essere stata poi continuamente bersaglio di hate speech online e di minacce, riassumibili nell’accusa, secondo lo stereotipo più vecchio del mondo, di essersela andata a cercare”.
Quella che resta, sempre e a prescindere, insomma, è la credenza consolidata per cui una donna che partecipa al discorso pubblico è comunque colpevole di occupare quello spazio, e quindi meritevole di stigma, anche se sta semplicemente svolgendo il suo lavoro.
Nel report sull’Italia diffuso a marzo da #Shepersisted, e parte di un’indagine internazionale più ampia sulla misoginia digitale rivolta alle donne attive nella sfera pubblica, le giornaliste, soprattutto quando impegnate nel dibattito o se fanno carriera, rientrano a pieno titolo nelle destinatarie della cosiddetta “disinformazione di genere”, una pratica al centro della fabbrica di post-verità e fake news diventata comune negli ultimi anni.
Il rapporto la definisce come la “diffusione di informazioni ingannevoli o imprecise con protagoniste donne dall’alto profilo pubblico”. Un processo che etichettando le professioniste in questione di volta in volta come abusive, privilegiate, incoerenti, brutte, bugiarde, inaffidabili e nemiche delle donne e dei bambini ha come risultato certo quello di screditarle, ritraendole come incompetenti e quindi incapaci di ricoprire le posizioni che occupano.
Del resto, in un paese di “donne a caso”, come apostrofa ironicamente ma non troppo un popolare profilo instagram impegnato in una rassegna a tema, mentre “troppe testate descrivono ambasciatrici, astrofisiche e scienziate semplicemente come mamme o mogli, chiamandole al massimo per nome, quasi mai per cognome o per titolo” sottolinea Maria Giovanna Sessa, ricercatrice sul tema della disinformazione di genere tra le esperte citate dal report di ShePersisted, sarebbe difficile aspettarsi qualcosa di meglio.
Nel 2021 la rete di giornaliste autonome Giulia, lo ha raccontato in un e-book intitolato Stai zitta giornalista, dove diverse interviste e un'inchiesta, inquadrano il linguaggio d’odio sui social come un rischio concreto di un bavaglio all'informazione, se non di una vera e propria censura nei confronti delle donne che svolgono un mestiere nel settore. Qui, spiegano le autrici, sono soprattutto le giornaliste che si occupano di temi considerati di competenza maschile – come sport, politica, giustizia – a essere oggetto di discorsi e campagne di odio online.
I dati sull’Italia erano già stati ben inquadrati da un’indagine uscita nel 2019 e condotta dalla Federazione nazionale stampa italiana su più di mille giornaliste. Il sondaggio – con l’85% delle intervistate che dichiara di aver subito molestie nel corso della vita lavorativa nell’ambito dei media, e il 66,3% che afferma di averle subite nei cinque anni precedenti – definisce quella delle molestie come “una realtà del quotidiano delle giornaliste nell’esercizio della professione”.
Questi dati fanno il paio con un paese in cui, come abbiamo già più volte raccontato su inGenere, i media non sono il regno della parità, sia perché le donne difficilmente occupano posizioni strategiche all’interno dell’industria che produce informazione e contenuti, sia per il modo in cui quell’industria le rappresenta.
L’ultimo monitoraggio del Centre for Media Pluralism and Freedom fotografa un mercato oppressivo in termini di libertà di espressione e pluralismo, con un indicatore di messa a rischio della parità di genere nei media al 72%, che colloca l’Italia tra l’Estonia e il Montenegro e ben distante da Lituania, Svezia, Regno Unito, Danimarca, Finlandia e Germania alle prime posizioni della classifica.

A pesare molto sull’indicatore, spiega il rapporto sull'Italia, è la scarsa presenza delle donne come attori politici nei notiziari (nel 2021 meno di 1/5 di questi attori erano donne, in linea con un trend globale dove è donna il 24% dei soggetti dei notiziari), ma anche negli affari e come esperte (nel servizio pubblico viene interpellata come opinion maker una donna nel 30 per cento dei casi, nel privato nel 22,8 per cento; con un trend globale che ha visto le esperte diminuire bruscamente nel discorso pubblico dal 18 al 12 percento nell’arco di pochi anni, dal 2015 al 2021).
In un modo simile la stampa italiana preferisce commentatori maschi nelle prime pagine, relegando le esperte alle rubriche femminili. Questa tendenza, spiega il rapporto, non corrisponde a una scarsità di competenze, dato che in Italia il divario di genere nell’istruzione è a favore delle donne con più laureate e più studentesse rispetto ai maschi.
La ragione è da rintracciare nell’assetto culturale e politico su cui l’intero settore è radicato. E se i media digitali anche in Italia sono riusciti in parte a invertire la tendenza, perlomeno nel linguaggio utilizzato (nelle notizie online i titoli professionali sono più di frequente utilizzati sia per le donne che per gli uomini e la loro articolazione grammaticale è più spesso sensibile al genere), l’indicatore complessivo riguardante la cosiddetta “alfabetizzazione mediatica” è passato da un rischio medio a un rischio alto, del 67%.
Un dato che il rapporto definisce preoccupante e “dovuto al fatto che non sono state intraprese iniziative politiche efficaci per migliorare le competenze e le abilità mediatiche complessive, sia per gli adulti che per i bambini, e alla posizione non soddisfacente dell'Italia negli indicatori europei sulle competenze digitali”.
L'Italia, spiega il rapporto “è drammaticamente indietro in termini di competenze di alfabetizzazione nel suo complesso”. L'ultima indagine internazionale sulle competenze degli adulti ha rilevato che il paese “è al di sotto della media Ocse nelle competenze di literacy”. In altre parole: la maggior parte delle persone che fruisce le informazioni prodotte dall’industria dei media non ha la capacità di leggere e comprendere un testo scritto. Un dato importante che ci parla di un sistema di istruzione sofferente, e dove competenze come quelle digitali, riguardano spesso strumenti tecnologici per le scuole ma non i programmi né la formazione di chi li insegna.
In ogni caso, fa notare il rapporto “la disinformazione in Italia non può essere attribuita esclusivamente all'ambiente digitale. Le notizie false o imprecise spesso provengono o vengono amplificate dai media tradizionali, per poi essere diffuse sul web (e spesso ritornano ai media tradizionali), formando così un circolo vizioso”. In questo circolo la bassa alfabetizzazione mediatica si mescola non solo a una generale sfiducia nei media ma anche e soprattutto a un livello di percezione del “pericolo di disinformazione” che rispetto al resto dell’Europa resta ancora troppo basso.
Finché non cambieremo la cultura sarà difficile anche solo immaginare che questi dati cambino. Nel frattempo, mentre leggi e politiche lentamente si adattano a quella che chiamiamo “la realtà”, ci sono delle cose che possiamo fare. Per esempio imparare a usare la tecnologia a nostro vantaggio, come spiega Michelle Ferrier, ex giornalista coinvolta negli attacchi del cosiddetto Gamergate del 2014 e inventrice di un “servizio di salvataggio per scrittrici e giornaliste che subiscono molestie online”; o l'esperta di media Kristina Wilfore in un toolkit per difendersi dalla misoginia digitale. E capire come abitare gli spazi digitali per rafforzare la nostra voce invece che autorizzarli continuamente a farci stare zitte.
Riferimenti
International media support, Online gendered disinformation and sexist hate speech, marzo 2023
Posetti J., Aboulez N., Bontcheva K., Harrison J., Waisbord S., Online violence against women journalists, Unesco, 2020
Irene Khan et al., JournalistsToo, Unesco, 2021
Osservatorio Vox, Mappa dell’intolleranza, gennaio 2023
Di Meco L., Apolito L., Armi di reazione e odio, marzo 2023
Giulia Giornaliste unite libere e autonome, Stai zitta giornalista, 2021
Federazione nazionale stampa italiana, Indagine sulle molestie sessuali nel mondo dei media, 2019
Carlini R., Trevisan M., BrogiE., Il pluralismo dell’informazione nell’era digitale, EUI, luglio 2023
Eui, Media Pluralism Monitor, 2023